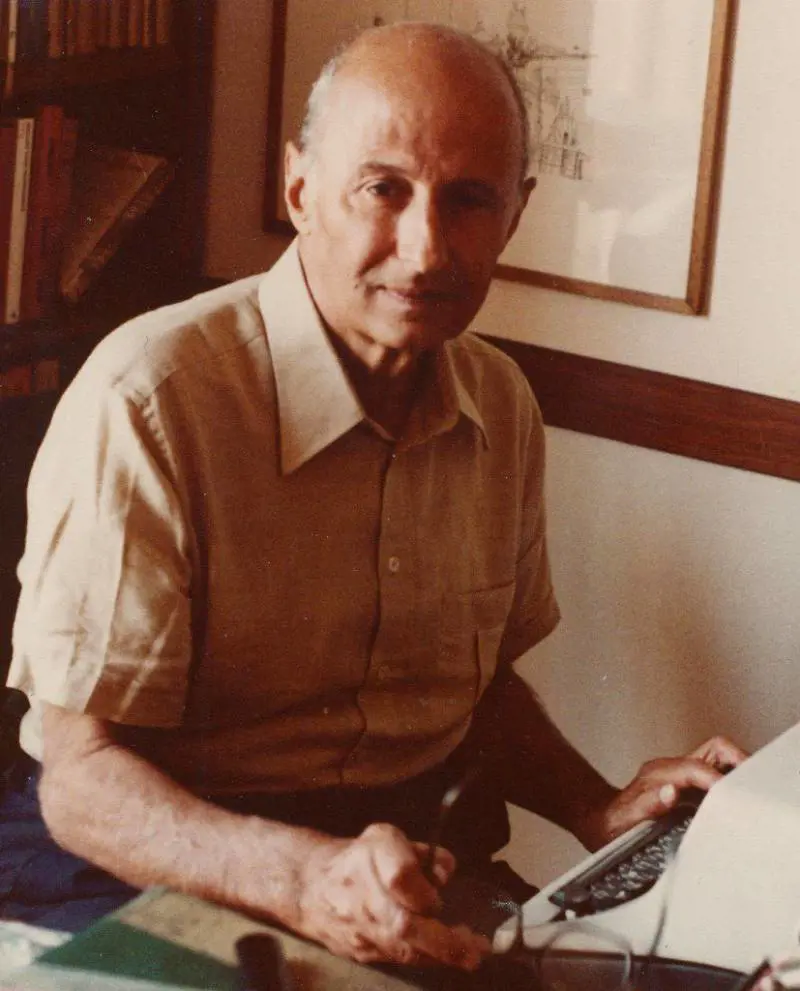
Davide Brullo
Il moloch e il molosso, la stele, il dolmen, l'ascia che in modo lapidario sega la testa della letteratura italiana del Novecento è Il quinto evangelio. Tanto vale dirlo subito, senza ghirlande retoriche intorno. Chi cita nel proprio anticanone privato Giorgio Manganelli o Tommaso Landolfi o Guido Morselli, è solo uno snob, costoro sono degli straordinari minori; chi cita Petrolio di Pier Paolo Pasolini non conosce l'abbecedario dell'arte narrativa, quello resta uno zibaldone di buone intenzioni romanzesche incompiute; chi cita Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo lo cita per sentito dire, non è andato oltre le prime venti pagine; chi cita Carlo Emilio Gadda, il vero antidoto al binomio scolastico Pavese+Calvino, lo cita perché gli hanno detto e bisogna accademicamente obbedire che Gadda è il massimo narratore italiano del Novecento. Il massimo narratore italiano del secolo scorso come se la letteratura fosse un perpetuo incontro di boxe in realtà è Mario Pomilio, ma non ditelo a nessuno, perché quando leggi Il quinto evangelio speri che sia scritto per te, ne sei geloso, ti chiudi nella soffitta più solitaria della stanza più remota, e lo divori, poi lo centellini, poi vi anneghi, come il cinematografico Bastiano Baldassarre Bucci che s'impantana nella Storia infinita. Il quinto evangelio, infatti, pubblicato nel 1975, anno in cui lo Strega onorava Tommaso Landolfi e il Premio Nobel andava a Eugenio Montale (altri tempi), mette in scena una ricerca. La ricerca forsennata di Dio. La ricerca filologicamente assatanata di una rivelazione ultima, intima, abbacinante, sintetizzata in quel «quinto evangelo inedito» il quale, una volta scoperto, ci precipiterebbe in «una storia del Cristianesimo da riscriversi da capo». Pomilio, in fondo, privo di ideologie, privo di una fede catechistica buona a rabbonire i puri di cuore, fa quello che ha sempre fatto la grande letteratura. Sfida Dio. Con un romanzo mostruoso. Ma è ora di giocare un po' con la cronologia. Nel 1945 Mario Pomilio si laurea alla Normale di Pisa, discutendo con Giovanni Macchia una tesi su Luigi Pirandello. Nello stesso anno un manipolo di contadini arabi, a Nag Hammâdi, scopre, scavando, alla ricerca di concime, una giara gigantesca. Sono spaventati. Pensano, spaccandola, di irretire torme di jinn, i geni, come quelli della lampada di Aladino. Il più impavido lancia una pietra. La giara fa crash e altro che invasione di geni indiavolati. Accade di peggio. La storia del cristianesimo cambia per sempre. Diventa, all'improvviso, tridimensionale, polimorfica, spaventosa. La giara, infatti, erutta uno stuolo di apocrifi: l'Apocalisse di Paolo e quella di Giacomo, gli Atti di Pietro e un florilegio di Vangeli gnostici, il Vangelo della Verità, quello secondo Filippo, il Vangelo degli Egiziani. Il più interessante di tutti, però, è il Vangelo di Tommaso. Connesso, in parte, ai Vangeli canonici, è una racconta di frasi di Gesù, di epigrammi privi di scenografia narrativa, spesso cifrati, certamente affascinanti («Colui che è vicino a me è vicino al fuoco»; «Quando vi spoglierete senza vergogna allora vedrete il Figlio del Vivente»). Nell'edizione Einaudi dei Vangeli apocrifi, pubblicata nel 1969, Marcello Craveri scrive che «non si è esitato a considerare il Vangelo di Tommaso come il quinto Vangelo e a ritenerlo degno di essere incorporato ai sinottici». Nel 1969 Mario Pomilio ha 48 anni, è sposato, con Dora Caiola, da cui ha avuto due figli, Annalisa e Tommaso, è già un romanziere affermato (con La compromissione, una dura confessione politica, nel 1965, ottiene il Campiello), e non ha timori, in un'epoca di certezze partitiche, a dichiararsi «uno scrittore in crisi».
La pubblicazione di quegli apocrifi, da lui annotata, lo esalta. Lo stuzzica con l'idea di un romanzo totale, impensato. Una sfida alla morte del romanzo. «L'idea del quinto Vangelo, del Libro dei Libri o dell'Apocrifo degli Apocrifi, che prolunga e reinvera perpetuamente il messaggio, l'idea del libro perpetuamente inseguito e perpetuamente nascosto il quale soggiace alle Scritture già note e di continuo ne modifica e ne amplifica il senso» germinò, per la precisione, lo ricorda Pomilio medesimo, «in una certa febbrile mattina dell'agosto 1969 (che trascorrevo, ricordo, in Abruzzo)». Uno scrittore, in effetti, se è tale e non è il mandarino del già noto, un burocrate della letteratura, passa la vita tentando di scrivere quel libro in grado di sbriciolare tutti i libri mai scritti; quel libro solitario, più autentico e veritiero, addirittura, del Libro, della Bibbia, della Scrittura.
Nel 1962 papa Giovanni XXIII vara il Concilio Vaticano II. Mario Pomilo, in quegli anni, ha già esaurito lo sprint politico (è passato dal Partito d'Azione ai Socialisti di Lucio Lombardo Radice all'abulia partitica). Nel 1954 ha esordito alla letteratura con L'uccello nella cupola, protagonista un prete, romanzo cattolico aggiornato al dopoguerra, diranno i critici, dove scrive l'autore «vi dominano i temi della perfezione e della salvezza individuali, dell'esame di coscienza, della colpa, della grazia, del pentimento, e ne sortiva una visione essenzialmente intimistica e moralistica della esperienza religiosa». Pomilio, equidistante dalle avanguardie come dal neorealismo, è letterariamente scorretto, senza padrini o paladini. Nello stesso anno in cui Pomilio firma il suo primo libro, «nel solco della narrativa del caso di coscienza», Alberto Moravia pubblica Il disprezzo, Beppe Fenoglio esce con La malora, Mario Soldati vince lo Strega con Le lettere da Capri e Alberto Sordi è Un americano a Roma. Pomilio c'entra poco, pochissimo, quasi nulla con il suo tempo. Il Vaticano II, per questo, è una specie di shock. In un articolo a posteriori, pubblicato su Il Tempo, nel 1975, Pomilio riconosce che grazie al Concilio ha capito che «di fronte alla tranquilla scolasticità delle altre filosofie, quella cristiana è l'unica veramente in movimento». Che vuol dire? Che «le tranquille certezze ideologiche e filosofiche sono tutte altrove, presso i settori non cristiani, presso i quali la cancellazione delle esigenze metafisiche comporta un curioso dommatismo della negazione, un agnosticismo tutto in orizzontale, un rifiuto dei rischi speculativi e al limite un mare di coscienze pacificate». Il cattolicesimo, al contrario, «in un tempo d'angustie ideologiche, di parole d'ordine, di slogan, di semplificazioni, di fanatismi, resta l'unico luogo dove l'uomo continui a interrogarsi».
Da qui, dalla novità del Vaticano II, comincia lo sforzo intellettuale mostruoso, prometeico di Pomilio (leggetevi gli Scritti cristiani, passati per Rusconi e riediti nel 2014 da Vita e Pensiero), che dice per primo ciò che oggi è ovvio ma che al suo tempo era eresia. Svela la grandezza letteraria della Bibbia, rilevando che sono le Scritture la vera scaturigine della grande letteratura occidentale («nessuna letteratura ci trasmette in ugual misura il senso dell'ampiezza, l'impressione della grand'aria, del non delimitato, del non temporale e in definitiva una sorta di sentimento e di smarrimento cosmici»). Denuncia prima di lui l'aveva fatto solo Lev Tolstoj i Vangeli come incredibile, infinita fonte narrativa. Al pari del «personaggio» Gesù, scrive Pomilio, soltanto Edipo e Amleto «suscitano altrettante inquietudini». Solo che mentre «Sofocle e Shakespeare sembrano conoscere, essi almeno, Edipo ed Amleto» gli evangelisti «letterariamente parlando sembrano essere di fronte a Gesù nella situazione dei discepoli di fronte alla domanda Ma voi chi dite che io sia?». Proprio questo carattere aperto, enigmatico, non finito dei Vangeli rende la loro lettura, ogni volta, «un viaggio di scoperta e una scommessa col mistero». Tutto questo, in sintesi, mettendoci pure la traduzione della Seconda lettera a Timoteo di San Paolo, allestita da Pomilio nel 1969 per la Tipografia Poliglotta Vaticana, prepara alla scrittura del Quinto evangelio. Che appare tanto strano, stralunato, che a leggerlo quarant'anni dopo non sembra neppure italiano. Il romanzo più importante di Pomilio pare una meteora schiantata sul corpo bubboso della narrativa italiana. Nell'«edizione definitiva» del Quinto evangelio, gonfia di apparati (e poco invogliante alla lettura), allestita da L'Orma Editore nel 2015, Gabriele Frasca, per darci una idea del romanzo, deve citare Vladimir Nabokov (Fuoco pallido, per lo più) e Anthony Burgess (Abba Abba) mentre Andrea Cortellessa balbetta qualcosa che sta tra L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon e Horcynus Orca di D'Arrigo con un pizzico di Petrolio di Pasolini.
Come inscatolare la superba stranezza del romanzo di Pomilio, così polimorfico? «Lei inventa, finge una documentazione con tanta perizia ed eccellenza storica e filologica, che ne nasce una perplessità, in quanto si è indotti a persuadersi che siano documenti reali e storici e filologici»: così, dopo una prima lettura, scrive Riccardo Bacchelli a Pomilio. L'indizio è decisivo. Pomilio, quanto a perizia filologica, ha mirato ad Alessandro Manzoni, il primo grande scrittore che ha teorizzato la supremazia della narrativa rispetto alla Storia, che pensava, con un romanzo, di dire una verità più autentica dei dati di fatto. E a Manzoni, Pomilio dedica l'ultimo, raffinatissimo romanzo, Il Natale del 1833, giostrato intorno alla omonima poesia manzoniana incompiuta costruito su materiali il carteggio tra Giulia Beccaria e Mary Clarke, l'ipotesi che Manzoni progettasse la scrittura del Giobbe e una riscrittura della Colonna infame del tutto apocrifi, necessari, però, a rendere spaziosa, plastica, forgiata da enigmi e da titaniche depressioni, la sagoma patria del grande Alessandro. Il romanzo-saggio, un centinaio di pagine che hanno il nitore di una icona, edito da Rusconi, fu ornato dello Strega, nel 1983, battendo di un soffio Il raggio d'ombra di Giuseppe Pontiggia. Anche il romanzo manzoniano, tuttavia, apparve come un oggetto non identificato nella narrativa all'italiana: Domenico Rea scrive a Pomilio che quel libro «mi ha dato, per la sua tenuta morale, le stesse emozioni ultimative dell'Ivan Il'ic di Tolstoj; del Typhoon di Conrad; Carlo Bo, d'altronde, in un saggio articolato, cita André Gide, Ernest Renan, Léon Bloy, François Mauriac, Albert Camus. Ancora una volta, Pomilio, altro che arcitaliano, è un antitaliano, un altritaliano, piuttosto.
«La storia d'un uomo, si sa, può cominciare in vari modi...». Torniamo nel 1945; è notte; siamo a Colonia; la Seconda guerra è all'apice, all'atto finale. L'ufficiale americano Peter Bergin è allocato in una canonica. Nella canonica scopre una biblioteca. Nella biblioteca scopre quaderni e appunti elaborati da un parroco. Nei quali si cita un misterioso «quinto evangelo», das fünfte Evangelium, per essere precisi. Il cristianesimo, «una religione chiusa e statica, quale l'avevo sempre giudicata, di poche, magre, remote, piuttosto assurde verità stabilite una volta», diventa, agli occhi abbagliati dell'ufficiale, un'avventura. Tornato in patria, l'ufficiale consacrerà la sua vita alla ricerca del «quinto vangelo», «il libro nascosto il quale soggiace alle Scritture già note e in perpetuo ne modifica e ne amplifica il senso». La trama, ricalcata da bestseller più o meno banali (da Umberto Eco a Dan Brown), buona per una saga hollywoodiana, si tramuta in un vertiginoso esercizio di stile. Il quinto evangelio, infatti, è orchestrato su due lettere, il botta-e-risposta (ma la risposta ci è negata per sempre, ennesimo colpo di scena letterario) tra Peter Bergin e un misterioso «Rev. M. G., segretario della Pontificia Commissione Biblica». In mezzo, c'è la mole, tonante, di documenti allineati da Bergin e inventati da Pomilio, manoscritti secenteschi, leggende medioevali, testi post-tridentini, brandelli di riforme liturgiche, flash di visioni mistiche, epigrafi di monaci, a testimoniare l'esistenza di «quel quinto vangelo che i papi hanno deciso di tenere nascosto perché il mondo cristiano non debba esserne stravolto». In appendice, procedendo per asfissianti e sfiziosi accumuli narrativi, la pièce di Bergin, «il punto d'arrivo» di un delirio notturno, Il quinto evangelista, dove Gesù è «indecifrabile, sfuggente; al limite un enigma». A essere stravolto da quel romanzo davvero indecifrabile è la narrativa italiana. Pomilio, doverosamente ristampato, un po' per esigenze di canone un po' per noia, lo si sopporta come qualcosa di siderale, di lontanissimo. Non lo si cita come Calvino, come Pasolini, come Pavese, come il più grande rivoluzionario della letteratura italiana del dopoguerra. Perché? Perché non inseguiva la cronaca né eseguiva trattati sociologici in forma di romanzo, pratica nefasta ma redditizia della narrativa nostra. Pomilio ha eseguito opere d'arte.
Senza paura della parola cultura, ha edificato opere somme, alte, difficili, contestabili, confrontandosi con Thomas Mann, con Flaubert, con Dostoevskij, con Marcel Proust. per essere vero. E la grandezza, in Italia, è imperdonabile.
