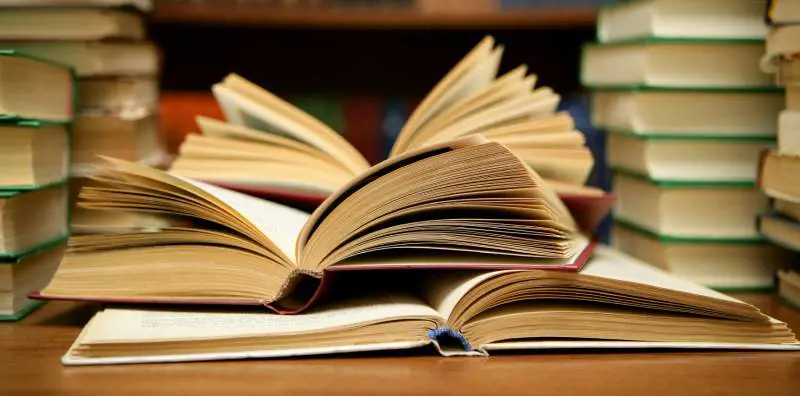
Oggi purtroppo parliamo la «neolingua» di Orwell
Militante e universale, radicato nella biografia dell'autore ed eterno. Un romanzo perfetto. In 1984 c'è tutto quello che viviamo e preferiremmo non vivere: la storia ridotta a randello ideologico, la «neolingua» del politicamente corretto, il «bispensiero» di chi sostiene tutto e il suo contrario a seconda dei desiderata del potere, lo stato di guerra permanente, l'odio mortale nei confronti dell'avversario politico, l'ipocrisia della casta di oligarchi innamorati del popolo a patto di non averlo mai tra i piedi, la mancanza di ogni regola (vietato vietare?) che si rovescia nella totale assenza di libertà, il controllo capillare della società per via tecnologica. Certo, Orwell non poteva prevedere che un giorno avremmo consegnato volontariamente la nostra vita, sotto forma di informazioni convertibili in statistiche, ai Grandi fratelli del web, e che i Grandi fratelli fossero più che altro interessati a fare buoni affari. Il socialista rivoluzionario George Orwell scriveva 1984 nel 1948 e aveva in mente lo stalinismo, oltre alle vie di Londra, trasfigurate ma perfettamente riconoscibili nella geografia del libro. Eppure, quando si arriva alla fine si capisce quanto 1984 vada al di là del contingente, e perché il titolo del manoscritto fosse L'ultimo uomo sulla Terra: «Ma tutto era a posto, adesso, tutto era a posto. La lotta era finita. Era riuscito a trionfare su se stesso. Ora amava il Grande Fratello». Winston Smith, funzionario del Ministero della Verità, addetto alla riscrittura del passato, è stato piegato dal Partito: ha rinnegato la donna che amava. Sulla Terra, dunque, non è rimasto alcun uomo capace di essere fedele a se stesso. Il conformismo trionfa. E conformismo significa quasi sempre tradire la nostra parte più autentica e vitale.
Le libertà di Tocqueville che salverebbero l'Italia
«Vedo chiaramente nell'eguaglianza due tendenze: una che porta lo spirito di ogni uomo verso nuovi pensieri e l'altra che lo ridurrebbe volentieri a non più pensare... Se al posto di tutte le varie forze che impedivano o ritardavano oltre misura lo slancio della ragione umana, i popoli democratici sostituiranno il potere assoluto di una maggioranza, il male non avrà fatto che cambiare di carattere». Sostenitore ma al contempo lucido critico della democrazia, Alexis de Tocqueville (1805-1859) è il padre del liberalismo europeo. Separazione dei poteri, certezza del diritto, rispetto per la religione come strumento di coesione, sospetto per il potere sempre più ampio concesso allo Stato, consapevolezza dei rischi di una «tirannia della maggioranza». Nel dibattito fra eguaglianza e libertà, Tocqueville opta per la seconda: uguali sì, ma solo davanti alla legge. Aristocratico, magistrato, diplomatico, Tocqueville nel 1831 viene inviato negli Stati Uniti per studiare il sistema penitenziario. Ne torna con un capolavoro pubblicato in due parti tra il 1835 e il 1840: La democrazia in America. Cosa comporta accrescere a dismisura il potere dell'autorità pubblica, anche in una democrazia? «Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini eguali ... Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare, che solo si incarica di assicurare i loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente e mite... Lavora volentieri al loro benessere, ma vuole esserne l'unico agente e regolatore; provvede alla loro sicurezza e ad assicurare i loro bisogni, facilita i loro piaceri, tratta i loro principali affari, dirige le loro industrie, regola le loro successioni, divide le loro eredità: non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?». Ricorda qualcosa?
Gogol' motore di ricerca fra sogni e incubi cittadini
Più della Parigi di Baudelaire e della Londra di Dickens, la Pietroburgo di Gogol' è la città della letteratura. Nei Racconti di Pietroburgo, la città ha infatti un ruolo al contempo marginale e fondamentale. Marginale in quanto le sue vie, i suoi palazzi, le sue piazze sono le mute, ieratiche quinte teatrali dietro cui si svolgono i drammi e le farse dei personaggi. E fondamentale proprio perché il suo essere «contenitore» delle vicende umane, tutte le giustifica e le motiva, imprime loro il sotterraneo impulso di pazzia che risale alla lucida follia dello zar Pietro il Grande: trarre dal nulla di una landa paludosa il colossale omaggio al proprio potere. Pietroburgo è dunque il Male, la violenza perpetrata sulla natura, eppure è anche il Bello, l'opera prometeica dell'uomo. Come tutte le città sorte prima e dopo di lei. Non a caso, nei cinque racconti troviamo il sogno come motore della narrazione. Un sogno alla Eyes Wide Shut (tratto da Doppio sogno di Schnitzler...) in La Prospettiva Nevskij; un sogno alla Poe o alla Kafka in Le memorie di un pazzo; un sogno estetico come nel Ritratto di Dorian Gray in Il ritratto; un sogno rivelatore, sia per il barbiere Jakovlevic sia per l'assessore di collegio Kovalev, in Il naso; un sogno fantasmatico per Akakij Akakievic, in Il cappotto. La città assiste con regale distacco alle miserie dei propri abitanti. È come New York per Woody Allen, come Milano per Alessandro Manzoni, come Lubecca per Thomas Mann. La città Pietroburgo prepara anche, inconsapevolmente, il terreno alle città industriali del '900 figlie della Metropolis di Fritz Lang. In esse avviene la «mutazione genetica» che le porta al centro della scena. Ma tutto nasce da quel geniale motore di ricerca chiamato Gogol', un Google che usava l'inchiostro invece dei link.
Sempre sia lodato l'individualismo di Miller
Eccessivo, irrequieto, impubblicabile (per ventidue anni, fino al 1961, in America fu censurato), refrattario a tutti gli «ismi» (specialmente i moralismi, ma anche le varie ideologie) e ai lavori «normali», sboccato, fuori posto: Henry Miller è il Tropico del Capricorno , il suo libro più importante, come l'autore l'aveva definito, il seguito di Tropico del Cancro , anche se come contenuto è antecedente, perché racconta della sua vita negli anni Venti a New York, quando non era ancora partito per Parigi, dove lo pubblicò nel 1939. Il Tropico del Capricorno è l'uomo Miller: è il romanzo della sua vita, che parla al singolo lettore, non al «pubblico» in generale, del quale peraltro diceva di non preoccuparsi. Perché lui scriveva «per i pazzi e per gli angeli», cioè chi ha le ali per volare, osa sognare, guarda le rovine della società e del mondo in fiamme come l'Angelus novus di Benjamin e vive solo nel presente perché sa, come gli scettici, che il destino è uno solo, «la tomba». Ma non per questo l'uomo-Miller si lascia andare alla disperazione. Soffre e quasi muore, ma la sua è sempre una «crocifissione rosea», una lacerazione da cui esce più appassionato di prima, più voglioso di vivere e stravivere: dopo la sua discesa agli inferi non scappa in Africa, non rimane nell'eternità dell'adolescente del suo amatissimo Rimbaud, in qualche modo diventa un adulto e - come ha notato Orwell - scrive «il libro di un uomo felice». Che sembra un paradosso, per uno «sempre contro», ma in realtà è l'estremo atto di sincerità di un uomo che fin da giovane capisce di essere «una contraddizione». Questo è il Tropico del Capricorno , flusso di coscienza di un (non) rivoluzionario senza ambizioni politiche: perché il suo unico obiettivo è l'affermazione della vita (e della letteratura) contro «i morti», tutto ciò che cerca sono l'espressione di sé, l'individuo e soprattutto la sua libertà.
La nave di Melville è l'arca del sapere e del saper essere
Il libro fondamentale per una civiltà, per una letteratura, per un Paese o semplicemente per una «comunità» di lettori, è quel libro che come una nave - una baleniera? - porta dentro e sopra di sé tutto l'occorrente per il Viaggio (l'unico che importa davvero, quello della conoscenza): un carico con tutto l'essenziale per l'uomo. Ciò di cui non può fare a meno: l'avventura, la scienza, la filosofia, l'epica, la religione, l'arte. Ecco. Il Moby Dick (1851) di Herman Melville - una sorta di Bibbia moderna: «Chiamatemi Ismaele»... - è un'arca letteraria che porta in salvo, per ogni singolo lettore, ciò che serve per preservare la specie umana. È un libro enciclopedico che dice cosa sono il Bene e il Male e come da sempre e per sempre confliggono; che racconta la fragilità, le paure, l'incapacità di stare in equilibrio sul mondo dell'essere umano, e la sua forza ancestrale nel rimanere aggrappato a qualsiasi cosa per sopravvivere; che celebra la volontà, che fa l'uomo; che narra dell'impulso naturale per la lotta, la sfida, la ricerca, la scoperta; che canta la bellezza e la ferocia della natura, e la misericordia e la severità di Colui che l'ha creata. Ma il romanzo - arca, bara e zattera di salvezza - contiene anche dell'altro, che ne rende esemplare la scrittura e irrinunciabile la lettura. Ed è la capacità di tracciare la rotta letteraria perfetta tra realismo e fantastico. Tra fatto storico: l'affondamento nel 1820 dell'Essex dopo l'urto con un capodoglio e l'uccisione nel 1830 della «balena bianca» Mocha Dick al largo del Cile. E la creazione artistica: lo scrittore che inventa la storia narrata dal narratore Ismaele. Un «osservatore» (Ismaele, il protagonista), il quale guarda un mondo (la nave Pequod) in balia di un uomo dall'animo mostruoso (il capitano Achab) e di un mostro dall'animo umano (Moby Dick). Cosa c'è di meglio da scrivere, e da leggere?
La lezione di revisionismo del Manzoni «storico»
Sradicare il falso, scavare le fonti per ribaltare la storia, estrarre il vero dal groviglio di luoghi comuni e bugie che l'hanno avvolto. Anche se è scomodo, imbarazzante. Così ha fatto Alessandro Manzoni nella sua Storia della Colonna infame. Certo, la vicenda della feroce e infondata condanna del barbiere Gian Giacomo Mora e del Commissario di sanità Guglielmo Piazza - che, il primo agosto del 1630, il Senato milanese condannò a essere «morsi con tenaglie roventi, mutilati della mano destra. Habere spezzate l'ossa degli arti, intrecciati alla ruota, dopo sei ore sgozzati» - l'avevano già raccontata in due. Il primo, Giuseppe Ripamonti, (1573-1643) ne parlò da uomo del suo tempo, seppur critico, nella sua De peste Mediolani quae fuit anno 1630. Il secondo, Alessandro Verri ne aveva preso, illuministicamente, spunto per il suo Osservazioni sulla tortura. Ma Manzoni va oltre. Verri guardava all'«oscurità» dei tempi e alle tremende istituzioni dell'Ancien Régime. Manzoni indaga, da cattolico, le responsabilità personali. Come i giudici forzassero la norma a caccia di un colpevole, come scelsero di tralasciare le leggi e le glosse che in qualche modo cercavano di limitare l'uso della tortura. Utilizza le fonti e le confessioni, la giurisprudenza del tempo, l'opinione comune - sempre così pronta a decidere chi è colpevole e a chiedere la condanna più spietata possibile - per mostrare come dalla paura nasca il male. Quelli che per i milanesi erano uomini stimabili, come il presidente dell'Uffizio di Sanità, il senatore Monti, si trasformarono in carnefici, perché non vollero vedere, vollero credere, o forse solo sedare la plebe. E Manzoni non li assolve. Lava i panni sporchi in pubblico. Quei panni che molti avevano ignorato o seppellito. Una lezione di metodo storico-letterario fondamentale. Ma qualcuno oggi come allora potrebbe chiamarlo revisionismo.
Da Pellico si impara l'autentico patriottismo
Chi parla più di Patria ormai? Il termine patriota non solo è desueto, ma è quasi considerato un insulto! Ci si raduna attorno alla bandiera solo per ignobili gazzarre automobilistiche in occasione dei mondiali di calcio, allora sì che ci si sente italiani. Nessuno più celebra il Risorgimento, l'unità d'Italia, i moti di Napoli e di Milano. Bazzecole! Chissenefrega! L'importante è festeggiare il 25 aprile e i partigiani, che per la retorica e la propaganda moderna sono i «veri patrioti» (soprattutto quelli che non c'erano o che hanno voltato gabbana). Per riscoprire le radici proviamo a guardare un po' più indietro, a coloro che hanno sofferto e lottato per unire la nostra povera italietta. A quelli come Silvio Pellico, Piero Maroncelli, Angelo Canova, Adeodato Ressi, Giacomo Alfredo Rezia, condannati a morte (i primi tre) per alto tradimento contro il potere austriaco... Quell'epoca, quell'epopea si riflette sui nostri giorni grazie a un libro come Le mie prigioni, il crudo eppur poetico memoir di Silvio Pellico e della sua detenzione che - grazie a un editto firmato da Francesco I d'Austria il 6 febbraio 1822 - fu graziato in cambio di quindici anni di carcere duro al famigerato Spielberg. «Ho io scritto queste memorie - profetizza Pellico - per vanità di parlar di me? Parmi d'avere avuto alcune mire migliori. Quella di contribuire a confortare qualche infelice coll'esponimento dei mali che patii e delle consolazioni ch'esperimentai essere conseguibili nelle somme sventure... Quella d'attestare che in mezzo a' miei lunghi tormenti non trovai pur l'umanità così iniqua, così indegna d'indulgenza come suol venire rappresentata». Pagine sofferte e ricche d'umanità che insegnano, dal carcere, cosa sia la vita quotidiana, l'etica, la religione («lascio la politica ov'ella sta e parlo d'altro») e paradossalmente di vera libertà.
Tra le bombe della Fallaci si leggeva già il presente
Paradigmatico e universale. Quindi attualissimo. Ora che il nostro Occidente rischia di diventare un enorme Libano infangato dalla guerra civile con cromosomi religiosi, Insciallah di Oriana Fallaci esce un'altra volta dai confini augusti del romanzo per tornare a essere la foto della nostra entropia sanguinaria e spesso sanguinosa, di quello scontro di civiltà che oggi ci fa sentire tutti a Beirut 1983. E poco importa che a uccidere i 241 marines e i 58 paracadutisti francesi (la scintilla da cui parte la Fallaci) siano stati i 5400 kg di gas esplosivo di Hezbollah o i kamikaze dell'Isis o di Boko Haram. Oggi, come allora, facciamo i conti con sfaceli come la «salsiccia umana», la bambina che un'esplosione macella e poi scaraventa in un water, e con quell'attonito, sordo sbigottimento di chi vede il buio persino nella luce e fa i conti con il caos che dilania ciò che resta dell'amore. In questo macramè di sventure, ambiguità ed eroismi in tempo di confusione guerrafondaia, ciascun protagonista di Insciallah è un carattere simbolico, da Charlie (a metà strada tra Lawrence d'Arabia e un contractor) fino al soldato Angelo, perso nella sua ottativa ricerca di una formula della vita (così tanto da far venire in mente Alekos Panagulis, amore sublime della Fallaci). Lì, tra i muri distrutti e la puzza di polvere sanguinolenta di Beirut, quella formula è rattrappita nel cupio dissolvi di «insciallah», sia fatta la volontà di Allah. Sembra oggi. Un angosciante ululato di cani, che tra l'altro paradossalmente apre e chiude le ottocento pagine.
Perciò provate a rileggere questo romanzo togliendo i connotati geografici o temporali e potrebbe essere ambientato oggi ovunque ci siano il nostro animo e i nostri soldati nel caos bulimico che mescola religione e odio in nome di un insciallah che cambia all'occorrenza. Quasi fosse semplicemente una regola d'ingaggio della morte.