Con Isherwood la scrittura sveglia dal sonno della vita
23 Novembre 2018 - 08:26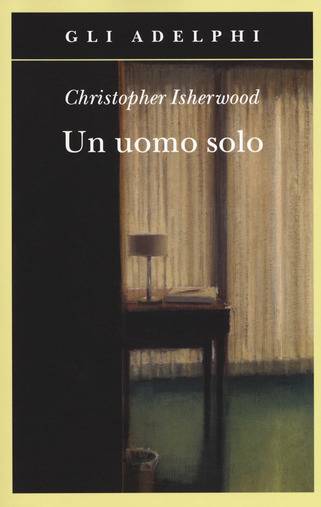
Nato in una famiglia della borghesia più puritana della campagna inglese nel 1904, amante di uno dei maggiori poeti del secolo, W.H. Auden, vissuto per qualche anno nella Germania che accoglieva euforica la follia nazista (si leggano Il signor Norris se ne va, 1935, e Addio a Berlino, 1939), poi emigrato in California, dove passò metà della sua esistenza col compagno di vita, l'artista Don Bachardy, fino alla morte nel 1986, Christopher Isherwood era un nomade a se stesso. Uno scrittore che ha fatto della sua diversità (l'omosessualità) la possibilità di un punto di vista davvero nuovo, sperimentando una possibilità «diversa» di vivere, e scrivere. Se Christopher spesso si nomina, non significa che dia per scontato il fatto di essere lui, in carne e ossa, sulla pagina, che teatralizza la propria vita. La sua non è una presa di posizione concettualizzante sul personaggio che dice «io». Quel personaggio è al contrario ottenuto per mezzo di una guerra interiore. Si potrebbe osservare che ciò male si concili con quella dichiarazione di poetica posta al principio di Addio a Berlino: «Io sono una macchina fotografica con l'obiettivo aperto: non penso, accumulo passivamente impressioni».
Come può conciliarsi quella «passività» con una lotta? Una risposta potrebbe darcela una dichiarazione che lo stesso Isherwood ha rilasciato a W.I. Scobie per la Paris Review: «Decidersi a scrivere può essere doloroso, e farlo, poi, meraviglioso. Dopo che ti sei imposto a te stesso, ti senti di nuovo bene». La scrittura compie un doppio processo, come di spersonalizzazione e, a lavoro compiuto, di riconquista di un io. Ma è nella spersonalizzazione che l'atto della scrittura si giustifica. L'io c'è ma non si riconosce. Riconoscersi come sconosciuti a se stessi è la sfida che impone la scrittura. «Il risveglio comincia con due parole, sono e ora. Poi ciò che si è svegliato resta disteso un momento a fissare il soffitto, e se stesso, fino a riconoscere Io, e a dedurne Io sono ora». È l'incipit di Un uomo solo, che Isherwood pubblicò nel 1964 e che torna di nuovo in libreria (Adelphi, pagg. 148, euro 12; trad. Dario Villa).
La scrittura è per Isherwood un sonno dal quale ci si sveglia, nella vita, stranieri a noi stessi. Il sogno di un nome che si vuole recuperare. Un uomo solo è il racconto dell'ultimo giorno di vita d'un professore, George. Ma perché Isherwood utilizza una terza persona anziché una prima? La terza persona non è altro che l'io più profondo di George. Un io che a George sembra sconosciuto. Ma il punto del romanzo è esattamente questo. Isherwood comprende che la scrittura e il proprio nome sono due soggetti estranei l'uno all'altro; soggetti che però fanno di tutto per coincidere. E non è un caso che, al termine del romanzo, quando George finalmente torna a dormire nello stesso letto in cui lo avevamo visto all'inizio del libro aprire gli occhi, percepiamo che quella terza persona non possiede più l'atteggiamento della prima. È la stessa scrittura che muore, o si addormenta allontanandosi inesorabilmente da quell'io che ora sa, proprio per mezzo della scrittura, qual è il suo nome.
George lo aveva detto chiaramente a Kenny, lo studente che lo provoca e lo eccita, che era necessario non «trascurare l'unica cosa che potrebbe cambiare completamente la vita». Cosa significa cambiarla se non accettare di conoscerla fino in fondo, essendo disposti a dimenticare ogni idea che avevamo di noi stessi, fino a toccare la carne viva del nostro nome?

