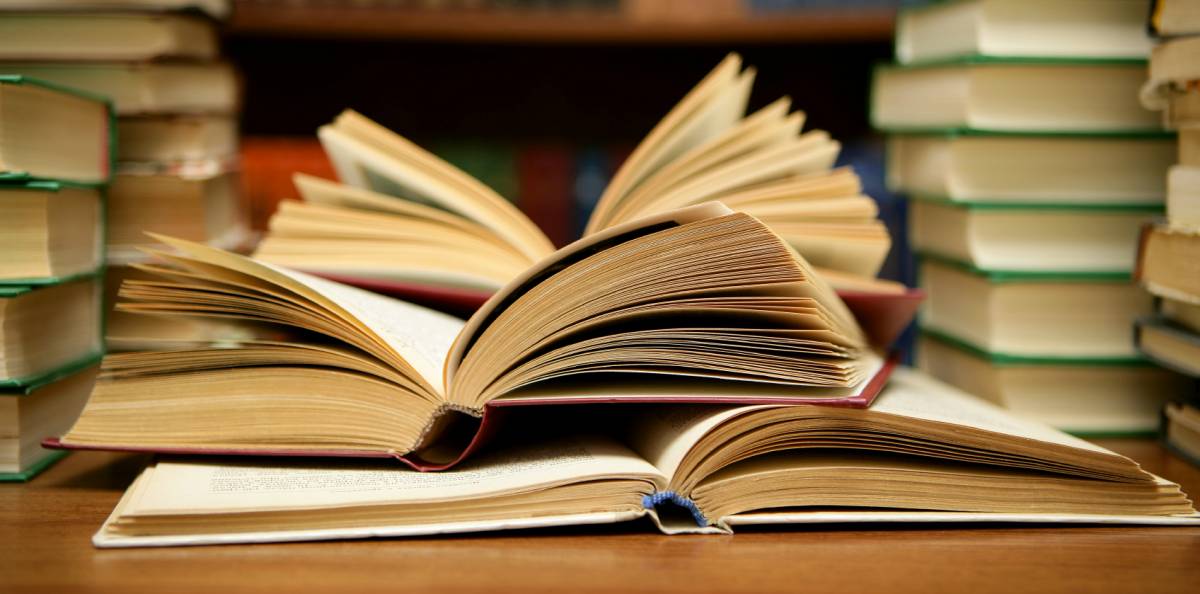
In questa stagione editoriale italiana si sta verificando una proliferazione di romanzi monumentali.A ottobre scorso è arrivato in libreria per Bompiani Le cose semplici di Luca Doninelli, che conta oltre 800 pagine. Il 17 marzo, per Rizzoli, uscirà il romanzo di Edoardo Albinati, La scuola cattolica (1300 pagine). Antonio Franchini, neo direttore editoriale di Giunti, in un'intervista a la Repubblica ha annunciato, oltre alla candidatura al Premio Strega del libro di Moresco (che non è certo estraneo alla monumentalità), anche l'uscita delle 2000 pagine de La vita vera è altrove di Giuseppe Montesano. E pare che sia particolarmente voluminoso anche il nuovo romanzo di Vitaliano Trevisan, che uscirà in aprile per Einaudi con Works.Occorre spazzare via prima di tutto ogni sospetto. Perché forse si sarà notato che gli autori che ho appena nominato, sono tra gli scrittori più interessanti, intelligenti e talentuosi che ci siano oggi in Italia (quindi non è neppure lecito pensare che la misura l'abbia dettata la presunta astuzia di un editor; qui non si parla di scrittori di genere, di giallisti, ad esempio, i quali sanno che l'attesa aumenta la suspance).
Autori che si sono distinti non solo per la loro opera narrativa, ma anche saggistica, e poetica, e teatrale. Non sono quindi narratori puri. Sembra, quest'ultima, un'osservazione di poco conto se non si tiene in considerazione che il romanzo è la forma d'arte per eccellenza più popolare, il mezzo espressivo in ambito letterario più frequentato dai lettori, e quindi pure lo strumento di cui meglio ci si può servire per far passare riflessioni sociologiche, teorie filosofiche, teologiche o scientifiche insomma, per trasmettere anche un pensiero, attraverso lo stile, e non soltanto raccontare una storia. Fin qui nulla di male, anche perché il Novecento ci ha abituato a una forma-romanzo non più, o non solo, tradizionale, ma aperta e ibrida (e bastino gli esempi di Joyce, di Proust, fino a Witold Gombrowicz, Malcolm Lowry, Lawrence Durrell e a tanti altri). Ma il punto è un altro. Da cosa nasce questa necessità di abbondanza, o di accumulo? Cosa nasconde questo bisogno di dismisura? Non suona un po' come un anacronismo?Del resto gli anni dei romanzi a puntate l'Ottocento di Hugo, di Dickens, di Dostoevskij, di Stendhal ecc. , dico il secolo in cui il romanzo era anche un mezzo di intrattenimento, uno dei pochissimi per la verità, è trapassato, e soprattutto ci appartiene poco come tradizione nazionale (dico l'Italia, che è per eccellenza e per natura il Paese della poesia e della novella). Ogni editor potrebbe senza ipocrisie confermarvi che agli autori dei grandi romanzi della tradizione ottocentesca, sicuramente oggi si sarebbero tagliate non poche pagine.
E allora perché opporsi con una soglia di sbarramento, una diga alla velocità del tempo che viviamo? Una controtendenza, una forma di snobismo o di superbia? Una volontà di potenza? O una paura? Ora è chiaro che sono io il primo a credere che ciascuna delle opere che ho qui nominato merita di essere letta e giudicata singolarmente, così come ho fatto, sto facendo e farò (posso già anticipare, sperando di parlarne più estesamente in altra occasione, che il romanzo di Albinati, seppure autobiografico, è più un saggio sociologico, psicologico e antropologico sui legami che intercorrono tra dominio e sesso, sesso e violenza, stato sociale, cioè denaro, e impotenza, e desiderio).Il critico Matteo Marchesini notava a ragione qualche tempo fa che un lettore che abbia affrontato fino in fondo un libro di mille pagine difficilmente ammetterà che quell'opera è brutta, perché altrimenti non saprebbe come giustificare il tempo che ha impiegato nell'impresa. Se fosse solo questo però, ci sarebbe la sola intenzione velleitaria dell'autore di stabilire un patto tra egli che scrive e colui che lo legge di non belligeranza, di ingiudicabilità, ovvero qualcosa che pone l'opera fuori da ogni giudizio (ma non credo siano poi molti neppure tra i critici quelli disposti a leggere dalla prima all'ultima pagina un libro di mille pagine di un contemporaneo, specie se italiano).
Ritengo questa osservazione, seppure di indubbia veridicità, solo parziale. Credo ci sia anche dell'altro; qualcosa che ha a che fare con la paura di scomparire (o di non aver fatto abbastanza perché questo non avvenga del resto nell'aspirazione a scrivere un capolavoro non c'è nulla di sbagliato, tutt'altro, solo occorre domandarsi quanto quell'aspirazione nasca da una reale urgenza, da una necessità). Ovvero che la propria opera non venga notata, o risucchiata nel vorticoso sistema delle novità editoriali, che vada a confondersi con ciò che letteratura, e quindi arte, non è ma si spaccia o passa per essere (d'altra parte mai come oggi alto e basso, arte e intrattenimento sono confusi in un grande calderone).Voglio dire che forse questa paura è legata alla propria posterità, al pensiero di cosa resterà di tutto quello che abbiamo studiato, custodito, pensato, e infine scritto. Solo che la posterità è un falso problema. L'opera, certo, è la sola cosa che conti realmente. Ma proprio per questo su di essa non abbiamo alcun dominio perché l'opera nel momento in cui è non ci riguarda già più, può fissarsi oppure confondersi nel mondo con lo stesso livello di probabilità.
E non è certo sfidando le leggi di gravità che si salderà al mondo; non occupando con una sovrabbondanza il maggior spazio fisico che si garantirà un posto nelle storie letterarie di domani. Del resto cos'è il romanzo se non una forma che aspira al perfetto equilibrio tra la lingua, cioè lo stile, i contenuti, e la struttura? Il contrario di una dismisura, insomma.