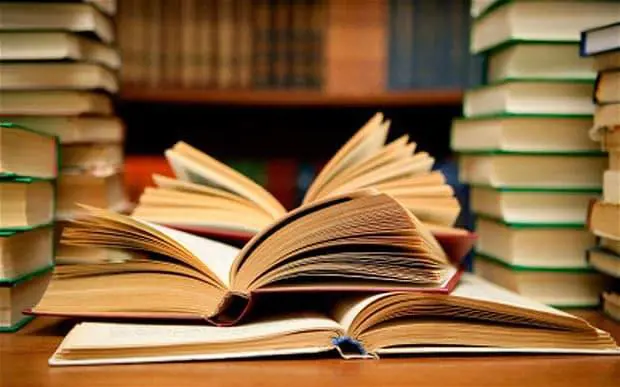
La domanda che oggi farei a un critico è: qual è l'opera saggistica che avresti voluto scrivere tu ma che invece ha scritto un altro? Se lo dovessero chiedere a me, risponderei che avrei voluto scrivere Lo spazio letterario di Maurice Blanchot (riproposto da Il Saggiatore nella nuova traduzione di Fulvia Ardenghi e con una postfazione di Stefano Agosti, pagg. 304, euro 29). Immagino già i sorrisini, i ghigni e i cinici commenti. Lo spazio letterario è un'opera profondamente novecentesca (uscì nel '55), di quella cultura francese che ha tradito la propria tradizione illuministica, che si è fatta volutamente oscura, oscenamente lirica, testardamente contraddittoria o, peggio, ossimorica e concettualmente astratta. Ma quel qualcuno che la giudicasse tanto frettolosamente, sbaglierebbe tutto. Blanchot ha scritto un'opera d'arte leggendone altre, cosa che a un critico odierno difficilmente riesce, e questo perché ha smesso di credere che un'opera d'arte sia un tutto in cui si mette in gioco la vita; che l'arte o la si vive come esperienza assoluta - quindi accogliendone anche le contraddizioni - o è molto meglio, nel senso di più utile e più sensato, occuparsi d'altro. Per questa ragione ogni opera d'arte è necessariamente anche un libro filosofico, che sia quindi capace di veicolare anche un pensiero e una visione, oltre che limitarsi a essere un racconto.
I termini più ricorrenti del libro - vuoto, assenza, mancanza, solitudine, esperienza, morte - e che Blanchot interpreta attraverso la lettura di Kafka, Rilke, Mallarmé, Hölderlin, indicano già l'approccio filosofico. Ma cosa vuole capire Blanchot per mezzo di questi termini? A me sembra che l'ossessione (la necessità) poetica di questo saggio sia andare alla radice di ogni opera d'arte; capire, prima ancora del significato, il senso di straniamento che l'assoluto di un'opera contiene.
Ogni opera d'arte che sia realmente tale tende a un'origine, che è la necessità che la determina e la sua stessa ragion d'essere. In questa origine l'opera è in assenza del suo creatore. O meglio: in essa vive una scissione. Colui che la scrive, seguendo quell'origine, è entrato in uno spazio in cui infinitamente muore. Scrivere è come scomparire. Accettare che lo spazio linguistico sia il sacrificio della nostra assenza (Blanchot, e lo dico come qualcosa di accessorio al discorso, a un certo punto della sua vita impose che non venissero più pubblicate da nessun quotidiano immagini che lo ritraessero). Che quello spazio sia un tempo fuori di noi, sia altro da noi. Che quello spazio sia la nostra intimità manifesta e, proprio in virtù del suo apparire e rivelarsi, non ci appartenga già più, perché entrata nell'eterno canto della realtà.
Blanchot, dello scrittore, trova un esempio emblematico in Orfeo. È lui il vero protagonista di queste pagine, nel senso che ne è la metafora prima: «Tutto si svolge come se Orfeo, quando disobbedisce alla legge perché si volta a guardare Euridice, così facendo, stesse invece semplicemente obbedendo all'esigenza profonda dell'opera, ovvero come se, grazie a questo impulso ispirato, egli fosse davvero riuscito a rapire agli Inferi la sua ombra oscura e l'avesse ricondotta a sua insaputa alla luce dell'opera». Scrivere, dunque, è un atto di violazione.
Ma, e questo ci fa comprendere Blanchot, quella violazione (disobbedire alla legge) significa dimenticare le regole stesse della vita, obliare noi stessi in ragione dell'opera: «Guardare Euridice senza preoccuparsi del canto, con tutta l'impazienza e l'imprudenza di un desiderio tale da farci dimenticare la legge, ecco cos'è l'ispirazione».
