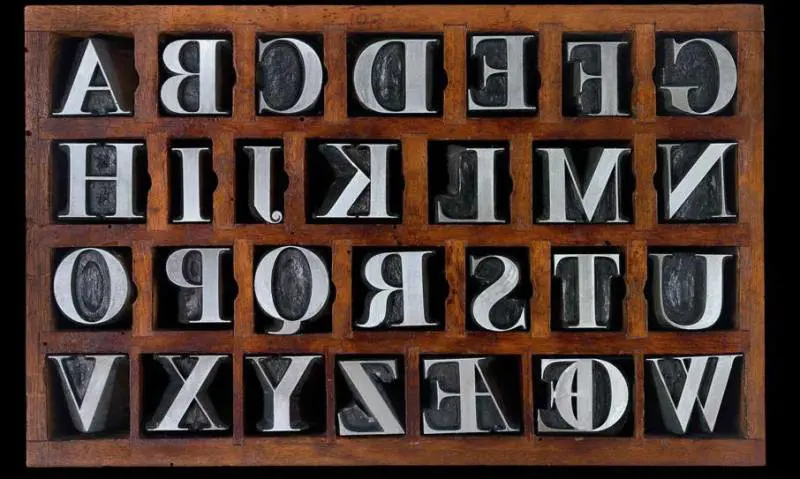
di Vittorio Macioce
C' è una terra, non troppo lontana, dove tutti parlano solo per frasi fatte. «A mio modestissimo parere», «la mia vuole essere semplicemente una critica costruttiva», «nella splendida cornice», «in tempi non sospetti», «patti chiari amicizia lunga», «onestà, onestà», «li aiutiamo a casa loro», «non esistono solo il bianco e il nero, ma ci sono tante sfumature di grigio, «non metteremo le mani nelle tasche degli italiani». Non c'è quasi mai nessuno che sfugge da questi canoni e all'inizio pensi che sia una combriccola di zuzzurelloni, una comunità di arguti linguisti che gioca con i sentieri più consumati della lingua italiana. Poi ti accorgi che non è un passatempo, ma una malattia. Le frasi fatte sono rassicuranti, non fanno paura a chi le dice e a chi le ascolta, non ti portano in territori sconosciuti e sono il modo più sicuro per venderti un messaggio. Non c'è neppure bisogno di pensare troppo, partono da sole, magari governate da un algoritmo.
In questo paese perso in un refrain ci sei capitato in compagnia di uno che da tempo va predicando contro gli assassini della lingua italiana. È uno strano tipo di conservatore libertario e si chiama Massimo Roscia. Ha scritto un libro che ha come titolo una frase fatta, ma di quelle in disuso: Peste e Corna (Sperling&Kupfer). Roscia da quando si è messo a raccoglierle ormai parla cosi: «Partito in quarta, rimboccandomi le maniche, gettandomi a capofitto in questo libro e iniziando, nei ritagli di tempo, a raccogliere tutte le frasi fatte, ovvero quelle frasi vuote, che passano di bocca in bocca, crescono come la gramigna, vengono ripetute fino alla nausea e, dagli oggi e dagli domani, fanno ridere i polli, rivoltare lo stomaco, perdere le staffe, accapponare la pelle, arricciare il naso, rizzare i capelli, venire il latte alle ginocchia e cadere le braccia».
Il guaio è che parlando così ti ritrovi a rivivere sempre lo stesso giorno, sempre uguale, senza varianti, fino a sterilizzare il futuro. Tutta la vita è uno slogan e un protocollo: la stessa risposta alle solite domande. È per questo che nella «terra delle frasi fatte» il grande nemico è l'inatteso. Non sanno come reagire a qualcosa di imponderabile e cominciano a insultarsi e a crocifiggersi gli uni con gli altri. Sono tutti vittime del cigno nero. Questo vale nella vita quotidiana, sul lavoro, in viaggio, in vacanza, nel calcio e a tavola. Come, appunto, si lamenta, Roscia: «I pistacchi devono essere tutti di Bronte (come se Bronte fosse grande quanto l'Iran), i pomodori tutti di Pachino (e non di Pechino), il lardo solo di Colonnata, le cipolle solo di Tropea, il parmigiano solo Vacche Rosse e stagionato almeno duecentoquaranta mesi in camera iperbarica, i gamberi, anche questi rossi, di Mazara del Vallo e le alici esclusivamente cantabriche (guai a parlare di Mediterraneo)».
Le frasi fatte sono anche un segno di identità, un lessico familiare che racconta un popolo. Solo che quelle di una volta ora ti sembrano più belle, quasi poetiche, con una storia dietro.
«Alla carlona» che tira in ballo una certa grossolanità di Carlo Magno o «fare un quarantotto» con gli echi rivoluzionari del 1848 o quel «pagare lo scotto» che viene dal franco skot, la tassa delle osterie. C'è un cimitero di frasi fatte perdute in questa terra non troppo lontana che assomiglia all'Italia.
