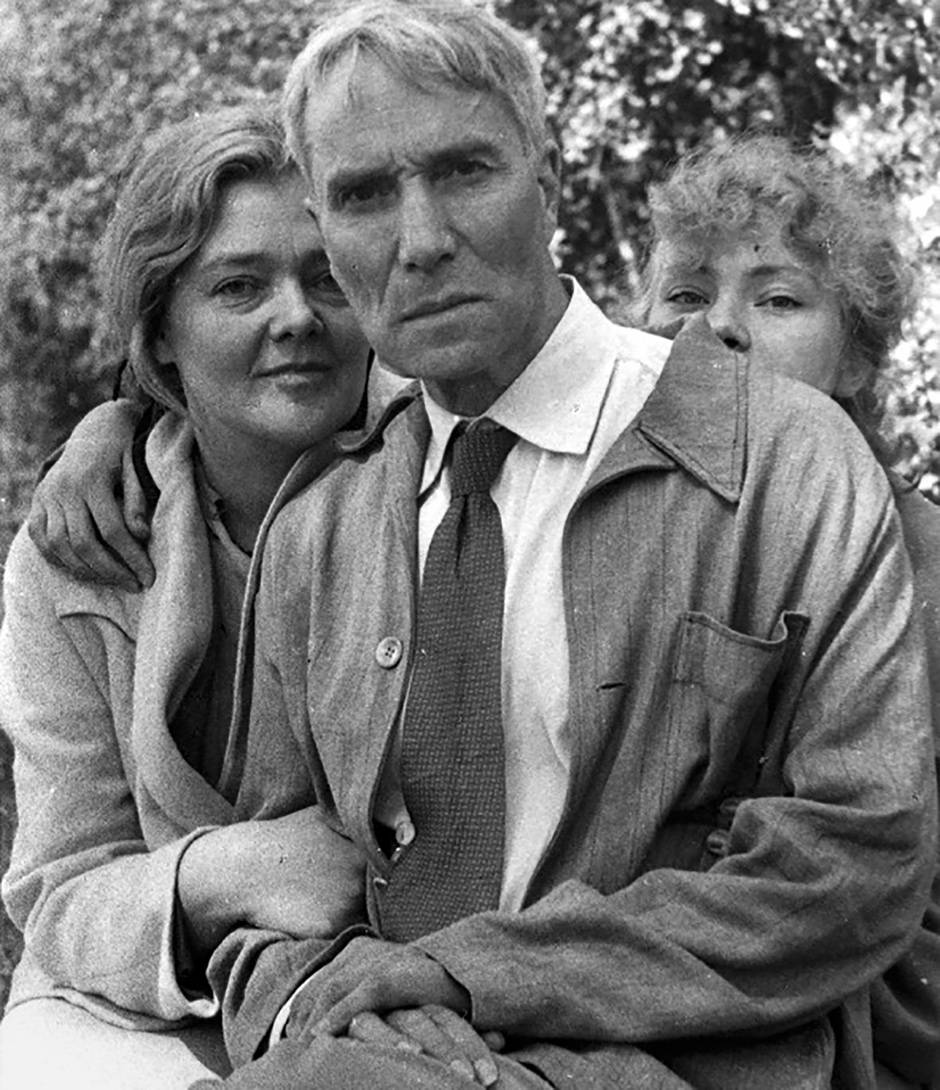
Le guardie arrivarono, proprio come mi avevano detto. Ogni notte si presentavano alla cella numero 7, prelevavano una detenuta e dopo diverse ore la riportavano, muta e con gli occhi rossi. Ogni notte stringevo i denti, convinta che sarei stata io la prescelta, eppure mi mancò il fiato quando vennero a prendermi per davvero.
Fui svegliata dal tocco di un manganello di legno sulla spalla nuda. «Iniziali!» sputò la guardia che incombeva sul mio letto. Gli uomini che venivano di notte chiedevano sempre le nostre iniziali prima di portarci via. Biascicai una risposta. La guardia mi ordinò di vestirmi, e non si disturbò a distogliere lo sguardo mentre obbedivo.
Percorremmo un corridoio buio, scendemmo varie rampe di scale. Mi chiesi se le voci fossero vere: se la Lubjanka si sviluppasse per ben venti piani sottoterra e fosse collegata al Cremlino tramite un sistema di tunnel, e se uno dei tunnel portasse a un bunker dotato di tutti i comfort pensato per Stalin durante la guerra.
Mi condussero in fondo a un altro corridoio, fino a una porta contrassegnata dal numero 271. La guardia la aprì appena, ficcò la testa nello spiraglio e poi la spalancò con una risata.
Al centro della stanza, un uomo in giacca militare sedeva dietro una grande scrivania. Sul ripiano c'erano cataste di libri e di lettere. I miei libri, le mie lettere.
«Si sieda, Olga Vsevolodovna» disse. Aveva la schiena curva di uno che ha passato la vita chino su uno scrittoio o intento a svolgere un lavoro pesante; a giudicare dalle mani perfettamente curate che stringevano una tazza di tè, propendevo per la prima ipotesi. Presi posto sulla piccola sedia di fronte a lui.
«Ci dispiace averla fatta aspettare» disse.
Attaccai con il discorso che preparavo da settimane: «Non ho fatto niente di male. Dovete lasciarmi andare. Ho una famiglia. Non c'è...».
Sollevò un dito. «Niente di irregolare? Questo lo verificheremo... col tempo.» Sospirò, mentre con la punta di un'unghia spessa e ingiallita cercava di togliersi qualcosa dai denti. «Perché ci vorrà tempo. Vorrei che lei fosse sincera con me, Olga Vsevolodovna.» Tirò fuori un fazzoletto macchiato dal taschino e vi si soffiò il naso. «Mi dica del romanzo che sta scrivendo. Ho sentito delle cose.»
«Quali cose?»
«Me lo dica lei» disse lui. «Di cosa parla Il dottor ivago?»
«Non lo so.»
«Non lo sa?»
«Lo sta ancora scrivendo.»
«Se la lasciassi qui da sola per un po', con un pezzo di carta e una penna magari potrebbe pensare meglio a quello che sa o non sa del libro, e mettere tutto per iscritto. Cosa ne pensa?»
Non risposi.
Si alzò e mi consegnò una pila di fogli bianchi. Prese dal taschino una penna placcata d'oro. «Tenga, usi questa.»
Mi lasciò lì con la sua penna, i suoi fogli e le sue tre guardie.
Caro Anatolij Sergeevic Semënov,
devo forse far finta che questa sia una lettera? Qual è la forma appropriata per cominciare una confessione?
Perché è vero, ho qualcosa da confessare, anche se non è quello che lei vuole sentire. Da dove conviene partire quando si deve confessare qualcosa? Dal principio, immagino.
Ma sapevo bene che non era questo che interessava ad Anatolij Sergeevic Semënov. Presi la penna e ricominciai daccapo.
«Caro Anatolij
Sergeevic Semënov,
Il dottor ivago (parla di un medico. parla degli anni tra le due guerre. parla di Jurij e Lara. parla della vecchia Mosca. parla della vecchia Russia. parla d'amore. parla di noi.*) non è un romanzo antisovietico».
Un'ora dopo, quando Semënov tornò, gli porsi la lettera.
La esaminò e se la rigirò tra le mani. «Ci riproverà domani notte.» Accartocciò il foglio, lo fece cadere e fece cenno alle guardie di portarmi via.
* La parte in corsivo nella parentesi è cancellata nel testo originale.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
