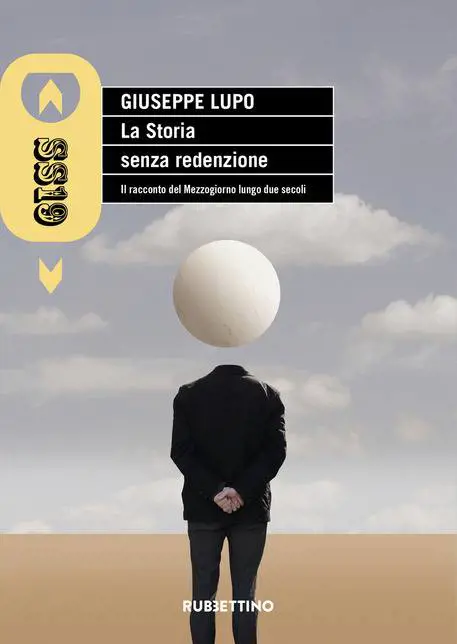
E se fossero stati gli stessi scrittori del Sud i primi a non credere nella modernità e nel progresso? A infilarsi nel vicolo stretto della non-Storia, confermando l'idea di un Meridione immobile, senza sviluppo e senza speranza? Se fossero stati gli intellettuali del Sud i primi colpevoli, fermandosi alla denuncia dei fatti invece di inventare nuove vie letterarie di redenzione e riscatto?
È l'idea che sta al centro del saggio di Giuseppe Lupo - non a caso italianista rigoroso e romanziere di grande invenzione - La storia senza redenzione. Il racconto del Mezzogiorno lungo due secoli (Rubbettino). Un libro che da una parte nasce da un senso profondo di appartenenza culturale (l'autore è un fiero lucano che fa i conti con la propria identità letteraria) e dall'altra da un originale presupposto «ideologico». E cioè che se guardiamo alla grande letteratura meridionale, da Giovanni Verga ai giorni nostri, ci accorgiamo - ecco la tesi - che gli scrittori del Sud hanno spesso scelto la via più facile di una narrazione cronachistica-documentale rispetto a quella forse più rischiosa inventiva-utopistica.
La prima (che Lupo chiama la linea del narrare «aragonese») è quella del romanzo di descrizione, è il realismo, è la tranche de vite che entra nel romanzo, oggi diciamo «non fiction novel», è la letteratura più accondiscendente, che accontenta il mercato: tu lettore vuoi che ti dica che il Sud è corrotto, mafioso, perduto, e io scrittore te lo dico. È il filone di Verga, De Roberto, del Pirandello de I vecchi e i giovani, di Tomasi di Lampedusa, del Consolo de Il sorriso dell'ignoto marinaio, di Carlo Levi, fino a L'inferno di Giorgio Bocca e al Saviano di Gomorra. Una letteratura che dà del Sud un'immagine tragica, malata, irredimibile. La seconda via (la linea del narrare «angioino») è quella invece della visionarietà, dell'onirico, del fantastico, che inizia con Boccaccio (il Decamerone è certo un libro fiorentino, ma molto napoletano, pieno di fantasia, di scherzo, di gioco, e infatti quando Pasolini gira il suo Decameron sposta l'azione a Napoli), passa da Lo cunto de li cunti di Basile e poi viene tradita, finisce (con rare eccezioni: certe utopie di Silone, Pomilio, Nigro, i quali pensano che la modernità sia una chance per il riscatto). Da un lato la scrittura «aragonese» vincente: quella dei Vicerè, di una lingua alta e segretariale, degli scribi, del racconto dei fatti nudi e crudi (oggi si direbbe del giornalismo d'inchiesta), spesso del tragico... Dall'altro la scrittura «angioina» perdente: dell'invenzione, del racconto condito di fantasia, dell'estro, della favola, del «romanzesco», spesso del comico...
Ecco. Giuseppe Lupo si chiede - qualcuno ribatterà? - cosa avrebbe potuto guadagnare una letteratura meridionale che si fosse affidata non (solo) agli scrittori che ratificano la realtà, ma anche agli scrittori che la reinventano. Cosa sarebbe successo se il Sud letterario invece di credere così poco nella Storia avesse concesso agli uomini la possibilità di riscattarsi. Se invece di raccontare il fallimento, la sconfitta, l'immobilismo, avesse scommesso sul sogno della Storia, sull'utopia progettuale, la costruzione dell'impensabile. Non solo il mondo (cioè il Sud) come è, ma come dovrebbe, e potrebbe, essere.
È una solo suggestione.
Ma al Nord Renzo Tramaglino nasce operaio e finisce - alla conclusione del romanzo - imprenditore. Al Sud Mastro don Gesualdo inizia come apprendista, diventa capomastro, si arricchisce ma - alla fine della storia - fallisce. E qualcosa vorrà pur dire.
