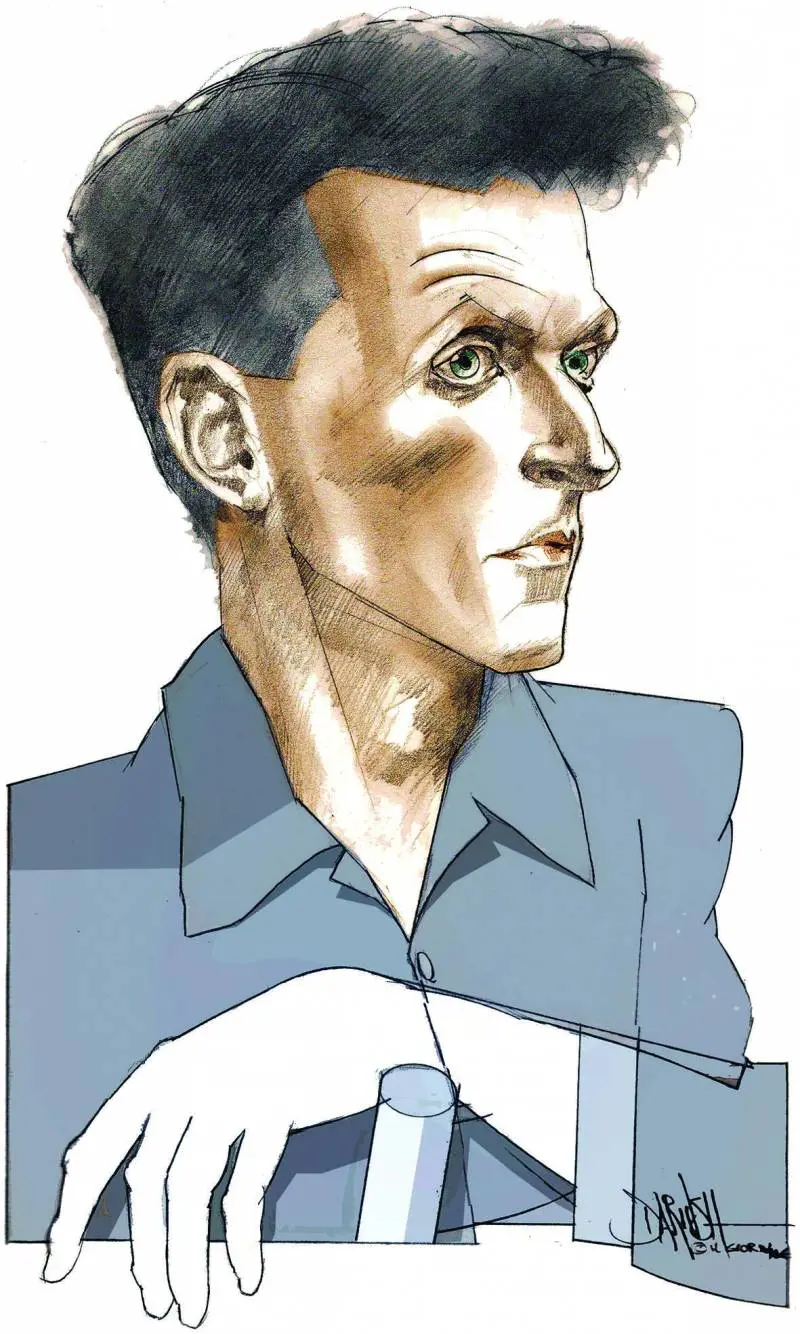
Bipolare, schietto fino all'impudenza, costantemente terrorizzato dal proprio fallimento filosofico. È il ritratto di Ludwig Wittgenstein che rimbalza nelle sue Lettere, 1911-1951, ora pubblicate da Adelphi (pagg. 601, euro 48). Con molto materiale inedito, tra cui i verbali degli incontri del Moral Sciences Club di Cambridge a cui il filosofo austriaco partecipò, spesso in lite con le tesi esposte dal conferenziere di turno.
Basti il suo racconto all'allievo Rush Rees della serata tenuta da Karl Popper nell'ottobre del 1946: «Una riunione orrenda, in cui un cretino, il dottor Popper di Londra, ha blaterato una stupidaggine dopo l'altra come da tempo non ne sentivo». Ma in Wittgenstein lo sberleffo non è posa, è l'uomo ad essere sulfureo prima del filosofo, e non è un caso che la raccolta si apra con una lettera all'amico e mentore Bertrand Russell in cui, ventitreenne, demolisce così la filosofia di George Edward Moore: «Quello che dice in tre pagine potrebbe benissimo stare in mezza paginetta. Le enunciazioni oscure non diventano più chiare per il solo fatto di essere ripetute!». Un giovane sconosciuto che maltratta uno dei due numi tutelari del pensiero britannico, scrivendo all'altro. Ma nel 1913 ce n'è direttamente anche per Russell, che aveva confessato di sentirsi «paralizzato» dalle obiezioni dell'enfant prodige alla sua teoria logica e aveva amichevolmente chiesto chiarimenti: «Una spiegazione delle indefinibili generali? Oh santo cielo! È di una noia tale!! Qualche altra volta! Sul serio, gliene scriverò una volta o l'altra, prometto, se per allora non avrà già capito tutto».
Il fatto, è che i suoi interlocutori riconoscevano a Wittgenstein la legittimità della stroncatura e fin dell'offesa, perché avevano scorto in lui il genio in grado di rovesciare la logica novecentesca. Ma, pur portatissimo, lui fu da subito insoddisfatto, compresso negli steccati astratti della materia, di cui cercava disperatamente il nesso con il mondo della vita, con le sue giornate e i suoi sbalzi d'umore, come infine espresse a Russell: «Come posso essere un logico, se ancora non sono un uomo! Devo chiarirmi le idee, per prima cosa!». Allora, si gettò nel calderone della Grande Guerra, tra lo sconcerto degli amici intellettuali. Ma, come scrisse nel 1915 a John Maynard Keynes, «si sbaglia di grosso se pensa che essere un soldato mi impedisca di pensare alle proposizioni». Non solo continuò a pensarci ma, nel campo di prigionia italiano di Cassino portò a termine il Tractatus logico-philosophicus, che inviò a Russell e a Frege (anche se quest'ultimo «non ne capisce una parola»). Il primo, invece, vi riconosce un'opera-cardine del Novecento, e ne agevola la pubblicazione.
Wittgenstein ritiene di avere speso col Tractatus la parola filosofica definitiva, di aver confinato nel «Mistico» tutti i problemi non chiarificati da un'analisi logica del linguaggio, e misticamente si ritira nell'Austria profonda e montuosa, a fare il maestro di scuola elementare. Ma nel 1922 scrive a Russell: «Sono molto depresso. Non c'è un'anima in questo luogo con la quale possa scambiare una parola ragionevole». Il problema non sono i bambini, sono gli uomini, e l'assenza assordante di «parole ragionevoli». L'università di Cambridge è ben lieta di accogliere l'autore del Tractatus. Di cui s'aggravano le tendenze maniaco-depressive, come testimonia una lettera a Keynes del maggio 1929: «Mi venne in mente che probabilmente pensavi che io coltivo la tua amicizia per poter ricevere da te un aiuto finanziario». Il grande economista sbottò: «Caro Ludwig, che paranoico sei!». Wittgenstein avvia una corrispondenza coi pochi allievi in grado di seguirne le provocazioni. A William Watson confida: «Sì, secondo me Einstein è solo uno schifoso giornalista», riferendosi al suo impegno militante contro le dittature e per la pace. Per lui, piuttosto, il problema è di filosofia del linguaggio: «Mi interessa sapere quali modi di dire useranno gli austriaci una volta diventati nazisti», scrive nel 1934 all'economista italiano Piero Sraffa.
Da parte sua, ha preso la cittadinanza inglese, e decide ancora una volta di sostenere lo «sforzo bellico»: presta servizio come inserviente al Guy's Hospital di Londra. Da lì, scrive all'allievo Norman Malcolm: «Mi rammarico che non posso fare filosofia, perché è l'unica attività che mi ha dato vera soddisfazione». Eppure, tornato a Cambridge alla fine del '44, rispuntano la perenne frustrazione concettuale e l'esigenza di saldare la filosofia alle urgenze della vita, che porteranno alla stesura delle Ricerche filosofiche. Sempre a Malcolm: «Che senso ha studiare filosofia se serve solo a metterci in grado di parlare con qualche plausibilità di astruse questioni di logica, ma non migliora il nostro modo di ragionare sulle questioni importanti della vita quotidiana?».
Finché la bestia, il cancro alla prostata, si fa viva. Così affrontata, in un'altra lettera a Malcolm: «Non sono rimasto affatto sconvolto quando ho saputo di avere il cancro, mentre mi ha sconvolto apprendere che si può curarlo, perché non provavo nessun desiderio di continuare a vivere». È l'inaridimento filosofico, l'angoscia di non poter dire e pensare più nulla di rilevante, che lo fa noncurante di fronte alla morte. Con uno scarto, in una lettera del 16 aprile 1951: «Mi è successa una cosa straordinaria. Circa un mese fa di colpo mi sono sentito nello spirito giusto per fare filosofia. È la prima volta dopo oltre due anni che questo velo che ho nel cervello si è aperto». Morirà tredici giorni dopo. Ancora una volta, insoddisfatto.
Un cretino che ha blaterato tutta sera una stupidaggine
dopo l'altra
Vuole spiegazioni?
Che noia! Un'altra volta. Prima o poi gliele scriverò...
