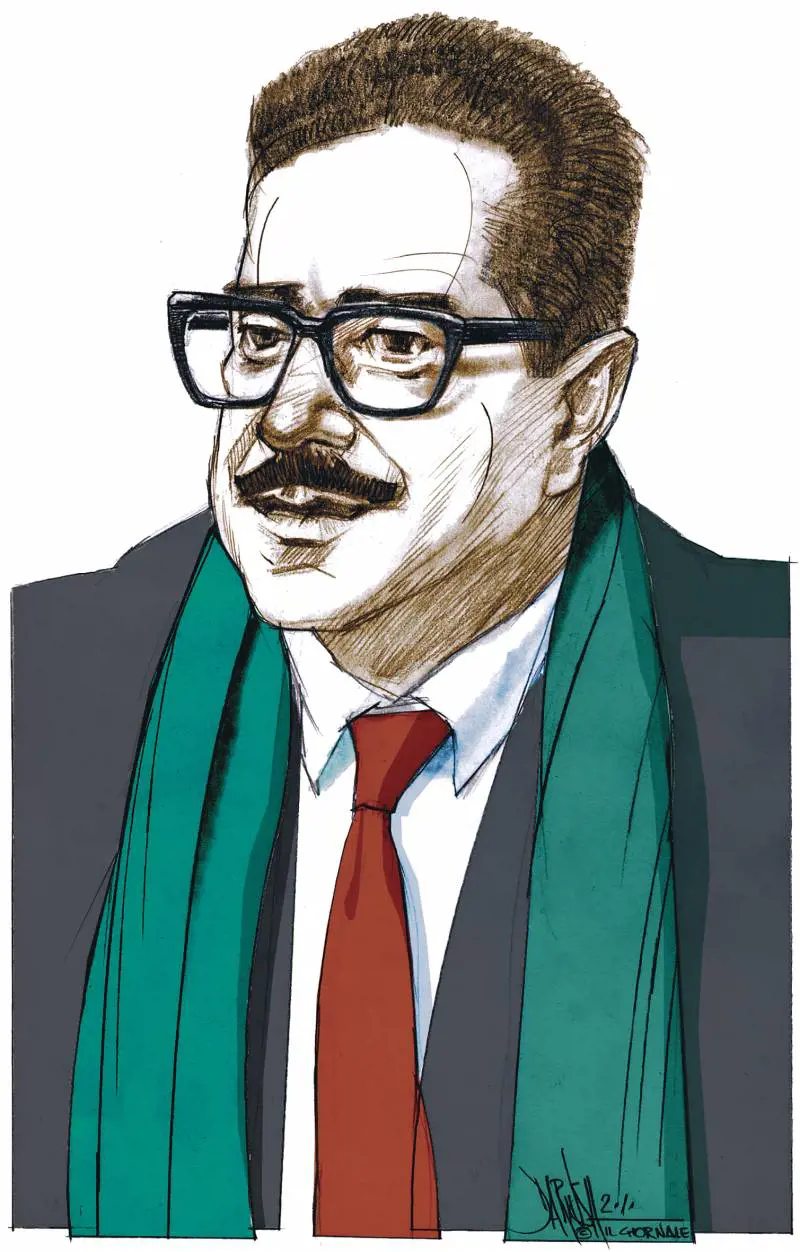
"Io non faccio critica cinematografica" disse Ennio Flaiano a Carlo Mazzarella, in un'intervista che non venne mai pubblicata. Mazzarella, dopo esperienze attoriali non esaltanti si stava avviando verso una carriera giornalistica che gli avrebbe regalato maggiori soddisfazioni (fra l'altro fu anche un collaboratore del Giornale), ma in quel 1960 probabilmente non aveva ancora le entrature giuste nella carta stampata o può anche darsi che, una volta lettala in copia, lo stesso Flaiano ci avesse ripensato, troppo drastica quella sua affermazione e ancor più severo il giudizio che la completava: "Il cinema non è arte, anche nel migliore dei casi. Nessun film mi ha mai commosso e potrà seguitare a commuovermi per tutta la vita (faccio i grandi nomi, tanto per capirci) come una sonata di Beethoven, due versi di Leopardi o di Catullo, un ritratto di Raffaello, un capitolo di Tolstoj o di Manzoni. Il film migliore commuove per un anno, tre, dieci, poi scopri i suoi limiti, rivela la sua natura, le spurie necessità che lo hanno prodotto, la permanenza nelle sue immagini di una realtà non trasfigurata... che il tempo rende goffe o incomprensibili addirittura. Il film migliore sfida appena la generazione seguente a quella che l'ha prodotto, poi diventa documento".
Per uno che si era ormai convertito quasi a tempo pieno in soggettista e sceneggiatore, ma che con il suo romanzo d'esordio, Tempo d'uccidere, aveva subito vinto il Premio Strega una dozzina d'anni prima, era un'ammissione non da poco, che oltretutto veniva a negare quello che più o meno in uno stesso arco di tempo, dal 1939 al 1951, Flaiano era stato, ovvero un critico che al cinema inteso come arte aveva creduto, qualcosa come trecento articoli fra settimanali e riviste specializzate, dove di volta in volta veniva dato conto di gusti e disgusti, indicazioni di metodo e osservazioni critiche, percorsi da seguire e trappole da evitare, tecniche di regia come di recitazione.
Chiuso per noia (Adelphi, pagg. 326, euro 16; a cura di Anna Longoni), che raccoglie tutte le sue recensioni e i testi sul cinema, consente ora di fare un po' il punto su quello che fu un amore infelice e/o una passione delusa, e il suo andamento cronologico permette una comprensione più diretta della posta in gioco, ovvero delle aspettative poi tradite dalla realtà con cui vennero in contatto. Flaiano esordisce come critico quando c'è ancora il fascismo, di cui ovviamente detesta sia il cinema d'evasione, i cosiddetti "telefoni bianchi", sia quello di propaganda. Se i secondi sono più smaccati e quindi più facilmente smascherabili, i primi sono più subdoli, perché danno allo spettatore una realtà distorta, non una "vita di riserva", in grado di dare un significato alla vita vera, ma una vita "colorata", in rosa, insoddisfacente e quindi irresponsabile. La caduta del fascismo, la nascita del neorealismo potrebbero indicare la strada giusta, assolvere, come dire, una funzione civile, solo che, anche qui, è la maniera a imporsi, la moda e quindi l'industria. C'è in quell'Italia sconfitta, degradata, marginale, lo stesso meccanismo per cui un'Ungheria cinematografica d'operetta si sovrapponeva all'Italia in cartapesta del Ventennio. Le cicche degli sciuscià prendono il posto dei bocchini in avorio delle duchesse, ma è la stessa agiografia, anche se rovesciata di segno, "un'Arcadia neorealista, probabilmente più irritante dell'Arcadia trapassata. Abbiamo visto film che davano la spiacevole sensazione di un viaggio in un tram affollato, odori compresi. Siamo penetrati controvoglia nei recessi più sordidi e intimi, senza che fosse necessario, ma solo per rendere omaggio alla retorica dei luoghi veri'".
Nell'Italia del dopoguerra, Flaiano si trova costretto ad ammettere che se "politicamente, durante il fascismo", il cinema era "sceso più in basso", mai era stato "artisticamente così in basso" come allora. Durante il fascismo chiosa, "uscirono film eccellenti, si formarono ottimi direttori, si gettarono le basi per la breve, famosa rinascita del dopoguerra. Oggi, finiti i turbamenti, finito anche il periodo dei registi-produttori, seppellito l'entusiasmo e mortificato il gusto, il cinema è tornato nelle mani di quegli speculatori che si credono astuti e anche benemeriti dell'industria". Se ai tempi del fascismo c'era stata la retorica coloniale e dell'Impero, la Nuova Italia dell'antifascismo si rivela un Paese coloniale: "Forse spaventati dall'idea di passare da provinciali, accettiamo tutto con riconoscenza. Siamo più esistenzialisti di Sartre, e più surrealisti del re; il futurismo ci fa ridere quando lo propone Marinetti, e incanta quando ritorna truccato da astrattismo. La verità è che molti italiani sono soltanto degli ottimi e incondizionati ammiratori" o, detto in altri termini, hanno la tendenza a "volare in soccorso del vincitore".
Nella Nuova Italia, scrive Flaiano sconsolato, "la genialità è il nostro forte, l'improvvisazione la nostra regola. Una sceneggiatura deve essere fatta in quindici giorni. Sarà poi riveduta dalla portinaia del produttore, o dalla sorella che riusciva tanto bene in italiano. Un orologio costa molto meno di un film, ma se al produttore si guasta l'orologio, mai si sognerà di farvi mettere le mani da qualcuno che non sia l'orologiaio. Un suo film invece è qualcosa che può essere toccato e aggiustato da chiunque. L'importante è fare presto, baciare la morta, tagliare la mano, innamorarsi della muta, accusare il fornaretto, e soprattutto incassare assegni, spesso però a vuoto. Si promettono premi al regista se finisce il film prima del previsto: e il regista lo finisce prima. Lo scrittore va al cinema a vedere il film che porta il suo nome, riconosce fra tutte un paio di battute e se ne vergogna".
È quella stessa Nuova Italia dove, parlando della cinematografica Napoli milionaria di Eduardo de Filippo, da un lato c'è quella "filosofia da scompartimento di terza classe che fa il mondo diviso in buoni e cattivi e che si appella al qualunquismo degli uomini per risolvere tutti i problemi, comprese le guerre e le sconfitte" e dall'altro, vedi La terra trema, di Luchino Visconti, offre "la perfetta conoscenza del bene e del male secondo i precetti progressisti (buoni i pescatori e cattivi tutti gli altri)", ovvero "quell'arte di partito che chiede agli iscritti più rinuncia e abnegazione che giudizio critico".
Come si vede da queste note sparse, la dittatura e il tempo della "ritrovata libertà" hanno in comune lo stesso pubblico, ovvero la stessa irresponsabilità del pubblico, a cui
produttori e registi si impegnano, tranne le solite eccezioni che confermano la regola, a dare lo stesso prodotto. E in fondo, come diceva un amico di Flaiano, "per indisposizione del dittatore, la democrazia si replica".
