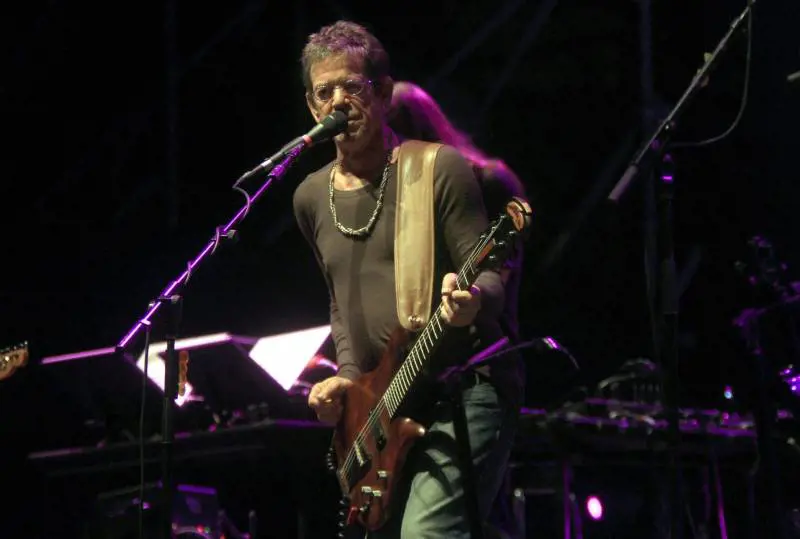
Però no, non può andarsene così uno che non è mai arrivato, che si è sempre perduto nei meandri dell'imperfezione perfetta, del suono dissonante. I Velvet Underground. Lui. Da solo. Lou Reed è morto ieri per l'ennesima volta, stavolta per davvero, dopo essersi giocato il fegato in cinquant'anni di eccessi ed averlo cambiato pochi mesi fa per guadagnare qualche mese di appello. «Tanto la mia sentenza è già scritta», diceva trent'anni fa. Ha preso per mano il rock, che manco gli piaceva così tanto, per dargli quel dolore letterario e quella profondità di sensi che non aveva mai avuto. Forse perché, lui nato piccolo borghese prigioniero dei luoghi comuni (a quattordici anni gli fecero l'elettroshock per sospetta bisessualità), ha costruito la sua musica per esser un luogo straordinario e talvolta repellente, sempre imprevedibile, totalmente opposto a quello che in fondo gli piaceva, ossia l'abitudine della vista, il rassicurante conforto della tradizione. Quando fotografa la sua città (ed era molto orgoglioso di farlo), non era la New York disperata a impressionarlo: ma quella rassicurante, il suo miraggio. Era questo, in fondo, che colpì Andy Warhol quando si trovò di fronte questo newyorchese ispido, appena laureato chissà come, taciturno quasi antipatico, così controcorrente da aver già preso in giro i banalissimi ballabili di metà anni '60 con un brano (The ostrich) e un'accordatura di chitarra che diventò il suo marchio di fabbrica. Come la voce, filtrata con il droning, né cantato né parlato. Aveva incontrato John Cale, violista in attesa di destino, e con i Velvet Underground e Nico nacque il più importante gruppo rock della storia americana. Ovviamente, come spesso accade, nessuno comprò i dischi e quasi tutti li ascoltarono dopo molti anni scoprendo che, ah sì, in quei testi c'era in effetti il lato oscuro della normalità, le perversioni, le droghe, le ossessioni che erano sempre rimaste nell'anticamera della musica popolare.
Il destino maledetto dei pionieri.
Warhol che respirava la loro stessa aria viziata e geniale del Village, se li portò in giro nel pazzesco spettacolo Exploding plastic inevitable: «Andy voleva vestissimo di nero così proiettava i suoi film su di noi: ma tanto eravamo sempre vestiti di nero». Litigarono. Si licenziarono a vicenda. Fecero esplodere i Velvet. Ai funerali di Warhol, increduli, Lou Reed e John Cale piangevano e nel loro disco Songs for Drella del '90, in quei testi violenti eppure poetici, c'è il Warhol vero, quello che voleva usarli come schermo ma che non li schermò mai e che oggi forse si è ritrovato un altro amico lassù. Dopo i Velvet, che comunque avevano inciso capolavori come Rock'n'roll o Sweet Jane o Venus in furs, quel che rimaneva di Lou Reed, piagato dalle droghe e dalle stimmate della paura, zampetta indeciso, pubblica un brutto disco omonimo e poi trova il suo alter ego razionale e glamorous, David Bowie, che gli produce Transformer, lo tiene in bilico mentre lui si concede il «walk on the wild side» (capolavoro), la camminata sui carboni fiammeggianti della perdizione. Concerti disastrosi (è un'icona terribile la sua foto mentre si inietta eroina sul palco). In Italia, nel 1975, lo show lo fece la polizia, staccando la corrente mentre Lou Reed guardava senza vedere. Poi baruffe ovunque. E solitudine. Come diceva Irwin Welsh, «la gente comincia a bucarsi soltanto perché, senza neanche rendersene conto, ha una gran voglia di un po' di silenzio», e Lou Reed lo cerca prima in Berlin, radiografia lisergica del suo divorzio, e poi in Rock'n'roll animal, Sally can't dance e nell'ossimoro Metal machine music, assordante, quasi cacofonico, una spugna per assorbire tutti i rumori della psiche.
Dalla deriva delle utopie Lou Reed esce a pezzi. Piazza qualche collaborazione (Nils Lofgren, Bruce Springsteen, Don Cherry). Aveva coinventato il glam, benedetto il punk senza essere né glam né punk e all'inizio degli Ottanta non era più niente se non l'unico americano, con Bob Dylan, che potesse pubblicare i propri testi senza musica. Poesia. Disperata. Lou Reed era un'icona senza immagine, nonostante il suo look (giubbotto di pelle nera, occhiali neri, broncio) sia diventato il look del rock. Sembrava un cratere che ribolliva impotente, senza lava. Litiga con il suo chitarrista, che era troppo cocco della stampa, e vagola per tutto il resto del decennio che diventò il suo purgatorio tra color che son sospesi. Come era stato all'inizio, fu Andy Warhol a ridargli la scossa. Morendo. Dopo Songs for Drella, se ne andò in giro con i Velvet Underground lasciando a casa la sua salvezza, Laurie Anderson, la polistrumentista che rianimò l'artista moribondo. Incide la trilogia del dolore (New York bello, Magic and loss di più) e se ne libera, forse per sempre. E dall'Ecstasy del Duemila (inquietante), Lou Reed inizia a fare i conti con il suo genoma creativo. Recita se stesso (pure in Palermo shooting di Wim Wenders). Racconta Edgar Allan Poe in The raven, che sarà uno dei suoi dischi destinati all'immortalità. Si fa prendere a bottigliate da pubblico e critica dopo il noioso Lulu inciso due anni fa con i Metallica.
E, per farci un dispetto, è l'ultimo disco di Lou Reed e forse lui godrebbe all'idea di essersene andato lasciando l'amaro nell'anima, come un vero punk, come un vero rocker, come uno che è stato troppe cose perché non gli piaceva essere raccontato sapendo già come va a finire.