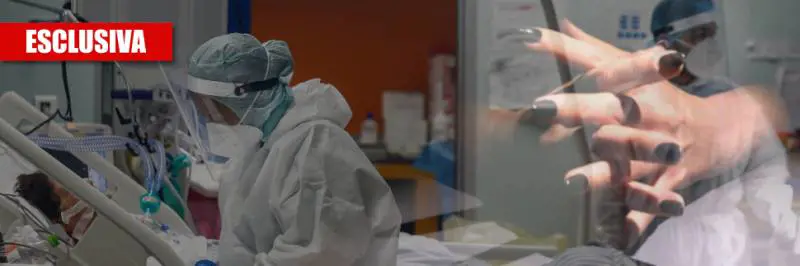
Pubblichiamo un estratto da Il libro nero del coronavirus (Historica Edizioni, 350 pagine, 20 euro), scritto da Giuseppe De Lorenzo e Andrea Indini.
Nei giorni successivi, all’ospedale di Alzano Lombardo, diventeranno positivi anche un primario e un caposala. Ed è proprio il pronto soccorso a finire nell’occhio del ciclone perché, dopo i primi allarmanti esiti dei tamponi, viene chiuso per la sanificazione, ma dopo solo un paio di ore viene riaperto. Succede tutto, nel giro di poche ore, la mattina del 23 febbraio. Delia, residente a Nembro, ha entrambi i genitori ricoverati in ospedale da diversi giorni. Passa a trovarli insieme al marito per dar loro una mano a mangiare. Giovanni, il padre, che da alcuni giorni ha la glicemia altissima, è in stato confusionale. Ad un certo punto sul cellulare di un compaesano, anche lui in reparto per assistere i propri cari, arriva un messaggio in cui si parla di un due casi di coronavirus nel nosocomio. Solo allora si accorgono che il via vai delle infermiere si è fatto sempre più frenetico e che la tensione sta aumentando di minuto in minuto. Quando il marito di Delia prova a tornare a casa, alla seconda rampa di scale viene fermato dagli infermieri e rimandato indietro. La comunicazione ufficiale tarda ad arrivare. Nel frattempo, però, le porte di uscita vengono sigillate e ai parenti dei malati vengono fornite mascherine chirurgiche. Fuori si può intravedere la calca di chi si presenta per le visite. Attraverso i vetri cercano di scambiarsi le poche informazioni che riescono a mettere insieme. Non hanno certezze. Ma, quando dalle finestre vedono giornalisti e cameraman aspettare davanti all’ingresso del Pesenti Fenaroli, capiscono che la situazione è davvero grave.
Verso le cinque di pomeriggio le infermiere piombano nelle stanze del reparto. «Tirate su tutta la vostra roba – intimano – e uscite di qui». Non c’è tempo nemmeno per salutare i parenti. Il marito di Delia prova a prendere tempo. «Non posso – spiega – c’è mio suocero in bagno». «Deve andarsene assolutamente – insistono – lo lasci lì che, appena abbiamo tempo, ce ne occupiamo noi». «Non siamo nemmeno riusciti a salutarlo...», ci confida con rammarico Delia che, insieme al marito, lascia il nosocomio senza alcun tipo di controllo. Non viene nemmeno formulata l’ipotesi di sottoporli al tampone. «Andate direttamente a casa – è il suggerimento che viene loro dato – lavate i vostri vestiti e fatevi una doccia». Gli infermieri si limitano unicamente a farli passare da un’uscita secondaria per evitare la ressa che, nel frattempo, si è formata all’ingresso. «Sembrava quasi dovessimo scappare...», ci raccontano. Ovunque regna il caos. Le sensazioni dei Morotti trovano conferma nella testimonianza di Nadeem Abu Siam, medico palestinese di 29 anni che il 23 febbraio dovrebbe fare il turno di notte. Alle 17 gli arriva la prima telefonata: «Siamo chiusi, non venire in ospedale». Due ore dopo il telefono squilla di nuovo. Gli comunicano che deve presentarsi al lavoro. «Appena entrato nessuno sapeva cosa fare – confida – il flusso dei pazienti era ancora fermo. Fino a quel momento non avevamo mai usato mascherine in modo generalizzato e in tutto avevamo una decina di tamponi».
Nei tre giorni successivi, inoltre, Delia continua a fare avanti e indietro dall’ospedale per portare il ricambio a entrambi i genitori. Il 27 febbraio, poi, la madre 82enne viene dimessa perché il tampone è negativo. Il suo, però, risulterà un falso negativo. Il 28, invece, è il padre a risultare positivo al test. L’incubo della famiglia Morotti era cominciato, però, a inizio mese, intorno al 10 febbraio, quando Giovanni viene portato per la prima volta al pronto soccorso di Alzano. Ha la febbre e la tosse gli toglie il respiro. La radiografia ai polmoni riscontra un inizio di focolaio. Viene, tuttavia, dimesso con una cura antibiotica. Nel frattempo anche la moglie inizia a stare male e per lei viene subito disposto il ricovero al Pesenti Fenaroli. Anche le condizioni di Giovanni peggiorano di giorno in giorno, nonostante le medicine che sta prendendo. «Gli si è ammalata la bocca», ci spiega Danilo, fratello di Delia. Perde completamente il senso del gusto e una violenta candidosi gli toglie l’appetito. Il 21 febbraio tornano, quindi, in ospedale e qui a preoccupare i medici sono soprattutto i valori del diabete. Da questo la decisione di ricoverarlo.

Delia e Danilo riescono a vedere il padre 85enne un’ultima volta il 9 marzo, la sera prima che muoia. «Vostro papà è gravissimo», dice il dottore in una telefonata arrivata nel cuore della notte. «Se volete potete dargli un ultimo saluto, ma non toccate nulla... nemmeno il letto». In testa non ha più nemmeno il casco, la C–pap. Ha solo la mascherina. «Ho provato a chiamarlo due o tre volte – ci racconta Delia – ma non mi ha mai risposto». I medici hanno già ini- ziato a somministrargli la morfina. «Morire per soffocamento non è degno di un essere umano», gli spiega con pazienza un dottore. «Sarebbe come morire annegati... quindi stia tranquilla che lo accompagneremo con la morfina». Per altre ventiquattr’ore andrà avanti a lottare tra la vita e la morte. «Secondo me – taglia corto Delia – di quel reparto lì, ne sono rimasti in vita davvero pochi...». Il 13 marzo anche la madre si aggrava. Questa volta l’ambulanza la porta al pronto soccorso dell’ospedale di Seriate. I medici non la porteranno nemmeno in reparto: morirà lì tre giorni dopo. «Nel frattempo mi sono ammalato io di polmonite bilaterale», ci racconta Danilo a cui non sarà mai fatto il tampone. «Non è necessario – gli spiegano – dal momento che non ha crisi respiratorie».
Per guarire, oltre agli antibiotici, un medico dell’ospedale San Raffaele di Milano gli prescrive anche l’antimalarica che, nel giro di un paio di giorni, gli spegne la febbre. Pure Delia si ammala, ma in forma molto lieve. Insieme a lei anche l’altra sorella e la nipote.
