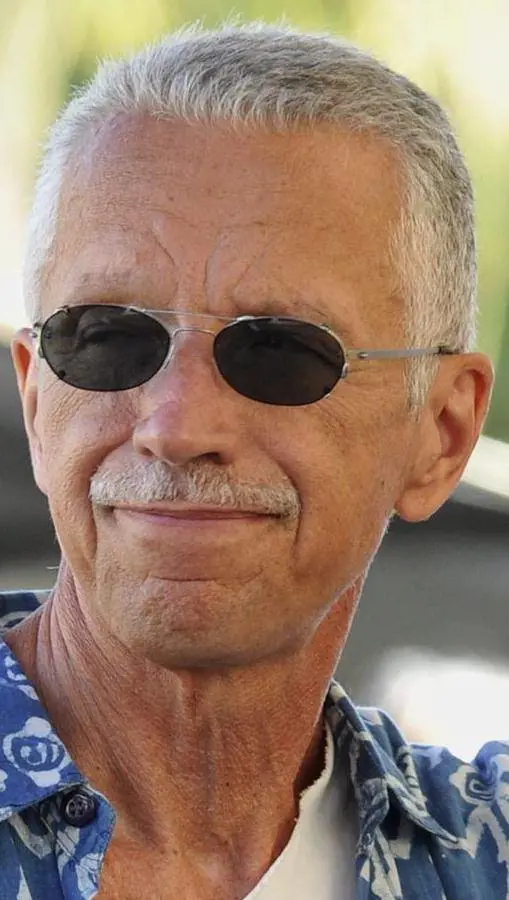
Tra i più incredibili risultati delle scorribande di Gengis Khan nella sterminata Asia, ci fu quello di influenzare geneticamente le generazioni a lui successive. Studi di genetica lo confermano: una vastissima discendenza imputabile al conquistatore si è formata nei secoli successivi e moltiplicata in moltissime parti di quel continente. Mi piace pensare che esista una genetica musicale, cioè quel percorso nel tempo che insemina, plasma e dona la direzione alle generazioni successive ogni volta che un capolavoro dirompente si affaccia nella storia.
Siamo in molti a essere figli di quella notte d'inverno del 1975. The Köln Concert ha geneticamente modificato il destino di migliaia di pianisti nel mondo negli anni successivi. Quella sera è comparso un nuovo modo di immaginarsi pianista, un nuovo modello da seguire valido sino a oggi. Il pianista si trasforma in condottiero solitario, un pianoforte come destriero per lanciarsi alla conquista di sterminati nuovi territori musicali. I vocalizzi, le smorfie, il suo corpo perennemente in movimento nell'intessere un vero e proprio atto d'amore con lo strumento, diventano i tratti distintivi di Keith Jarrett che, nel gennaio 1975 non aveva ancora trent'anni. Con lui siamo di fronte a un creatore-medium capace di trascendere da ciò che intendiamo e chiamiamo realtà. A fare la differenza è il suo profondo stato di concentrazione che lo proietta fuori dalla condizione ordinaria di attenzione, una sorta di trance possibile attraverso un preciso stato meditativo.
La particolarità del concerto di Colonia dimora prima di tutto nel linguaggio utilizzato, ma c'è molto altro. C'è per esempio che quando qualcosa arriva a imporsi nel mondo è perché arriva al momento giusto. Musicalmente gli anni '70 potevano contare su di un pubblico attento e aperto alle sperimentazioni. Quello che doveva essere un disco jazz per gli amanti del genere, abbatte in poco tempo ogni confine d'ascolto. La musica che ti s'infila sotto pelle al primo ascolto è un centrifugato di meraviglie di generi musicali creato con sapienza, tecnica stratosferica e potente semplicità: ci trovi Prokofiev ed Elton John assieme che se la ridono. E poi trilli barocchi, contrappunti, cavalcate gospel, armonie del più puro Novecento storico, pause inattese e colpi di pedale che fanno sembrare vivo quel piccolo e malconcio strumento. Quel pianoforte non all'altezza della sala e dell'esecutore è solo uno degli elementi che creeranno la leggenda attorno a quella sera, perché quel giorno si è rivelato innanzitutto come la storia di un uomo che combatte il destino avverso trasformando i problemi in opportunità.
Il 24 gennaio 1975 Keith Jarrett arriva al Teatro dell'opera di Colonia dalla Svizzera, in auto e con un po' di febbre. Lo strumento richiesto non è stato consegnato, al suo posto trova un piano mezzacoda con problemi di meccanica e scordato. L'artista decide di annullare il concerto e da questo momento seguono ore di trattative disperate con la tenace organizzatrice diciassettenne, Vera Brendes. Manfred Eicher - manager e discografico del pianista - sembrerebbe abbia fatto molto per calmare le acque. Alla fine Jarrett accetta di suonare, gli accordatori si mettono al lavoro, il concerto è previsto per le 23, dopo una replica di un'opera lirica in cartellone. E in questa giornata segnata dal destino non può mancare una cena servita con ritardo enorme e il conseguente arrivo del pianista in teatro poco prima del concerto.
Come iniziare un concerto totalmente improvvisato su di un pianoforte scadente mai più provato dal pomeriggio?
È qui la leggenda prende il volo. In diverse interviste Jarrett ha sempre denunciato l'estrema difficoltà dell'inizio, perché per chi come lui determina una storia in tempo reale, il primo grappolo di note o di accordi disegna il destino dell'intero concerto, esattamente come l'incipit di un romanzo. Mi immagino Jarrett in camerino: c'è un gruppetto di note che può sentire, cioè il campanello di avviso che il teatro utilizza per segnalare al pubblico l'inizio dello spettacolo. Ecco il colpo di genio: sol-re-do-la, ecco le quattro note con cui iniziare il concerto, quelle del campanello dell'Opera di Colonia. Ed è proprio così che inizia il concerto, parte della platea se ne accorge e scoppia in una grossa risata, alzando il volume la si sente nitidamente. Se oggi, celebrando il cinquantesimo anniversario del concerto, possiamo eseguire e portare al pubblico questa meraviglia, lo dobbiamo all'intuizione di due folli giovani giapponesi, che nel 1991 - con il benestare dello stesso Jarrett - trascrissero il concerto nota per nota. È uno spartito non perfetto, con refusi e parti oggettivamente impossibili da trascrivere su pentagramma, tanto che nel suonarlo non puoi far altro che tenere come riferimento l'incisione originale.
Nell'eseguire questo spartito non ha senso pensare di risuonarlo come l'autore, è inutile quanto impossibile. L'estremo atto di riconoscenza che si può vivere nasce proprio da un approccio diverso: non stai suonando musica precedentemente scritta e ragionata, stai dando vita nota per nota a un miracoloso atto di congiunzione di un uomo con gli stati più alti della creazione. Uno stralcio da un discorso ufficiale di Jarrett del 2003 durante la consegna del Premio Polar ci aiuta nella comprensione del miracoloso processo di creazione da lui generato: "La musica è nell'aria e tu puoi decidere di trovarla o meno. Se non la trovi non hai fatto abbastanza. Puoi essere educato in ogni modo nello studio della musica, ma tu sei ancora zero fino a quando non decidi di lasciare andare ciò che ti trattiene.
E la maggior parte di noi non lascia che ciò accada".Quando e se arrivi ad avere la forza di lasciare andare ciò che ti trattiene e di lasciare che tutto accada, allora può capitare di regalare al mondo qualcosa di incredibile, come accadde il 24 gennaio 1975 a Colonia.
