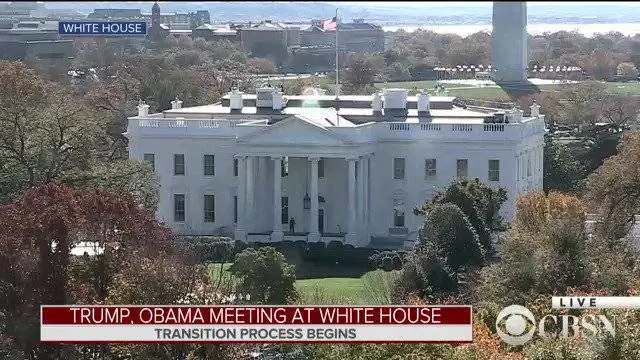
Ci sono tre promesse, tra le molte fatte da Trump nel corso della campagna elettorale, che potrebbero modificare radicalmente la scena mediorientale: il trasferimento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, la fine della opposizione all'allargamento degli insediamenti ebraici già esistenti in Cisgiordania, il proposito di «stracciare» l'accordo con l'Iran, noto come Jpcoa, faticosamente raggiunto da Obama lo scorso anno nella speranza di fermare, o almeno ritardare, la corsa degli ayatollah verso l'arma nucleare, ma che Truump ha definito «il peggiore trattato mai concluso».
Se le mantenesse tutte tre (ed è un grosso se, visto che non conosciamo ancora il nome del futuro Segretario di Stato), si guadagnerebbe l'eterna riconoscenza di Israele ma susciterebbe reazioni furiose nel mondo arabo e imprevedibili ritorsioni da parte di Teheran, con cui, sia pure sotto traccia, gli Stati Uniti collaborano attualmente nella guerra contro l'Isis. Il trasferimento dell'ambasciata comporterebbe, finalmente, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico: un riconoscimento che gli Usa e il mondo intero (Italia naturalmente compresa) hanno sempre negato in base a una vecchia risoluzione dell'Onu che voleva dare alla città uno status internazionale. Di conseguenza, nonostante gli stretti rapporti con Israele e l'unificazione della città sotto sovranità ebraica dopo la guerra del 67, Washington continua a considerare Gerusalemme come «illegalmente occupata». Per la verità, il Congresso aveva cercato fin dal 1995, con un voto quasi unanime di Senato e Camera, di porre rimedio a questa assurda situazione con il Jerusalem Embassy Act. Poiché, tuttavia, il presidente ha l'ultima parola in materia di politica estera, la legge gli lasciava la scelta del momento di applicarla; e sia Bill Clinton, sia George Bush, sia Barack Obama hanno preferito ignorarla, per timore di una rottura non solo con i palestinesi, ma anche con gli Stati arabi alleati. Se Trump, invece, seguisse le indicazioni del Congresso, metterebbe la parola fine alla disputa e risponderebbe anche alla recente, vergognosa risoluzione dell'Unesco che nega ogni legame tra l'ebraismo e la città.
Ancora più dirompente sarebbe la decisione di non opporsi più all'ampliamento degli insediamenti, che era diventata una autentica ossessione per Obama e il principale motivo della sua rottura con Netanyahu. Ancora la settimana scorsa, Washington si è premurata di condannare la costruzione di 181 nuove unità abitative nel nuovo quartiere di Gilo, che si trova sì al di là della cosiddetta linea verde, ma su terreni regolarmente acquistati dal Fondo nazionale ebraico. Per l'amministrazione uscente, ogni allargamento degli insediamenti, anche di quelli che, in un ipotetico accordo di pace, sarebbero sicuramente rimasti ad Israele, costituiva un ostacolo alla ripresa dei negoziati. Se ora gli Stati Uniti cambiassero politica (e magari fossero seguiti da altri Paesi occidentali), scatenerebbero la furia dei palestinesi e renderebbero ancora più difficile la auspicata soluzione dei due Stati, ma prenderebbero anche atto di una realtà irreversibile.
Gli specialisti di Medio Oriente si chiedono se Trump, vagliati i pro e i contro, passerà dalle parole ai fatti: ma la proclamata ostilità del neopresidente, e di diversi dei suoi più importanti consiglieri (in particolare, del generale Flynn) nei confronti dei musulmani fa pensare che la promessa elettorale non rimarrà sulla carta. La denuncia dell'accordo con Teheran (egualmente inviso ad Israele, perché lo considera privo delle necessarie garanzie) è molto più complicata. Esso ha infatti altri sei contraenti Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina, Germania ed Unione Europea - che difficilmente seguirebbero l'America su questa strada, anche perché hanno già avviato lucrosi contratti con l'Iran. Semplicemente «stracciarlo» sarebbe perciò per l'America un autogol. Tuttavia Trump potrebbe non applicarlo per la sua parte, o appellarsi alle violazioni già commesse dagli ayatollah aumentando la produzione di acqua pesante e sperimentando nuovi missili per imporre nuove sanzioni. Uno dei grandi oppositori dell'accordo è stato fin dall'inizio Mike Pompeo, ora nominato a capo della Cia.
Ci sono tuttavia importanti controindicazioni: anzitutto, la fine del Jcpoa farebbe il gioco dei «duri» iraniani che vi si erano opposti, mettendo in difficoltà i moderati del presidente Rouhani; in secondo luogo, lascerebbe liberi gli ayatollah di riprendere la corsa al nucleare, con la sola, pericolosissima alternativa militare per fermarli.
É perciò probabile che, anziché stracciarlo, Trump tenterà anzitutto di rinegoziare l'accordo, per renderlo più stringente. Ma visto che per concluderlo c'erano voluti quasi dieci anni di esasperanti negoziati, è più presto detto che fatto.
