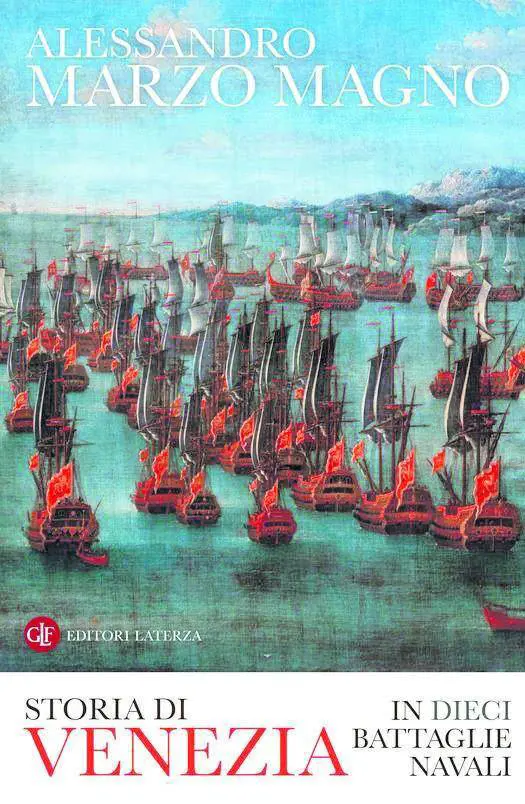
La Serenissima doveva tutto al mare, lì aveva dato corpo liquido a un sogno di palafitticola potenza, protetto dall'acqua salsa. E sull'acqua salsa protendeva la sua impalpabile rete di dominio: dal mare giungevano ricchezza, informazioni, prestigio. L'Adriatico lo stagno di casa, si potrebbe dire coi termini odierni era percepito come territorio. Per i veneziani, a partire dal Medioevo, non c'era differenza giuridica tra i più recenti domini di terraferma e quello più antico sull'acqua: anelavano sul mare allo stesso tipo di controllo che esercitavano sul suolo, e per qualche secolo, ci sono pure riusciti.
Ecco perché Alessandro Marzo Magno in Storia di Venezia in dieci battaglie navali (Laterza, pagg. 260, euro 20) guarda alla storia veneziana dal versante della battigia, dal punto di vista della maggiore potenza navale del Mediterraneo (e non solo di questo mare chiuso) della fine del Medioevo e della prima età moderna.
Una supremazia difesa a colpi di galee e galeazze ma anche di toponomastica e diplomazia. Fino alla caduta della Repubblica il 12 maggio 1797 l'Adriatico era chiamato Golfo di Venezia. Per giustificare il possesso di questa superficie liquida, i veneziani si sono persino inventati una battaglia: quella che apre il volume.
Si tratta del molto presunto scontro di punta Salvore (Savudrija), in Istria. I Veneziani, a secoli di distanza, si inventarono di sana pianta di aver battuto, nel 1177, la flotta di Federico Barbarossa, guarda caso - secondo loro - composta soprattutto da galee dell'acerrimo nemico genovese. Una vittoria mai avvenuta che, però, assegnava a Venezia un dominio assoluto sul mare, perché ottenuto con la sola cosa che il diritto internazionale, ieri come oggi, riconosce sino in fondo: la forza delle armi.
Non che questa invenzione assicurasse di porre fine alla questione. Una leggenda (riportata nell'introduzione da Marzo Magno) racconta che Papa Alessandro VI, alla fine del Quattrocento - quando la forza della Serenissima stava diventando debordante avesse domandato a Girolamo Donà, ambasciatore di San Marco presso la Santa Sede, dove fosse scritto che l'Adriatico appartenesse a Venezia. La risposta poco diplomatica del diplomatico fu: "Sul retro della donazione di Costantino, vostra Santità". A prescindere dalla veridicità del fatto, non dimostrabile, quel che conta è che rende bene l'idea della caparbietà veneziana sul tema, tema sul quale per il Doge, e la sua burocrazia, contava spuntarla ad ogni costo.
Le rimanenti nove battaglie, invece, sono state davvero combattute. Una, Lepanto, oggi ha eclissato tutte le altre; è l'unico nome evocativo per chiunque, quasi fosse stato il solo scontro navale disputato e vinto dai veneziani. Non solo non è vero, ma, come spiega sempre Marzo Magno non si è nemmeno trattato della vittoria più clamorosa dell'Armata (così era significativamente chiamata la flotta).
La "vittoria tra le più memorabili di tutti i secoli" è quella del 1656 ai Dardanelli. I veneziani, siamo nella quinta guerra veneto-ottomana, sbaragliano, anzi annichiliscono i legni della Sublime porta, lasciando letteralmente senza navi il sultano. Ma mentre a Lepanto le unità col vessillo di San Marco erano circa la metà della flotta collegata, ai Dardanelli avevano retto da sole tutto lo scontro, salvo sette galee dell'alleata squadra maltese.
Il trionfo fu totale anche se ottenuto a caro prezzo: il capitano generale veneziano Lorenzo Marcello venne ucciso da una palla di cannone che lo prese in pieno, ma la sua morte venne mantenuta segreta sino alla fine dello scontro per ordine del suo secondo in comando, il provveditore della flotta, Barbaro Jacopo Badoer. Insomma un successo in stile Nelson a Trafalgar, dove l'eroismo si fonde con una serie di innovazioni tattiche: ai Dardanelli per la prima volta è prevista una stretta collaborazione tra legni a vela e a remi, per la prima volta la flotta schiera tutta la sua potenza. Tanto che Maometto IV fuggì da Costantinopoli aspettandosi di veder arrivare la serenissima Armata, cosa che però non accadde. I veneziani si permettono pure di replicare la vittoria l'anno dopo, anche se in maniera meno netta. Nessun altro nei successivi 260 anni sarebbe riuscito a portare un attacco ai Dardanelli; lo avrebbero fatto i britannici soltanto nel 1916, con una differenza fondamentale.
Mentre i sudditi della Repubblica di San Marco vincono gloriosamente le due battaglie, ma perdono la guerra, i sudditi della corte di San Giacomo perdono rovinosamente la battaglia, ma vincono il conflitto. E così come il trionfo di Lepanto non consente alla Serenissima di recuperare Cipro, l'aver prevalso ai Dardanelli non salva il possesso di Creta (Candia per i veneziani). Venezia scontava delle fragilità non secondarie. È infatti particolarmente interessante il capitolo che Marzo Magno dedica alle artiglierie. Come spiega: "La Serenissima ha dominato per qualche secolo i mari, il merito va certamente alle sue navi e ai suoi marinai ma - in misura maggiore rispetto alle altre potenze navali - anche alle sue artiglierie e ai suoi artiglieri. La Repubblica riusciva ad imbarcare poca fanteria, era poco innovativa nella costruzione delle galee, la direzione delle guerre era affidata a organismi sovrabbondanti... a tutto questo suppliva però la qualità dei suoi cannoni". Le hanno consentito per tantissimo tempo di mitigare la demografia che favoriva i suoi enormi nemici. Poi inevitabilmente i rapporti di forza cambiarono e arrivò il canto del cigno: la lotta, a colpi di bombardamenti navali per piegare, nel periodo 1784 - 1786, il bey di Tunisi, Hammuda Ibn Alì. Dopo la decadenza. Ma questa è un'altra storia.
Non resta che segnalare che tra le nove battaglie navali vere del saggio Marzo Magno ne mette anche
una combattuta sull'acqua dolce. Quella di Polesella del 1509, perché Venezia coglieva successi tra i flutti salati, ma trovava molto amare le acque del Po dove venne annientata. Come? Con l'artiglieria, ironia della sorte.
