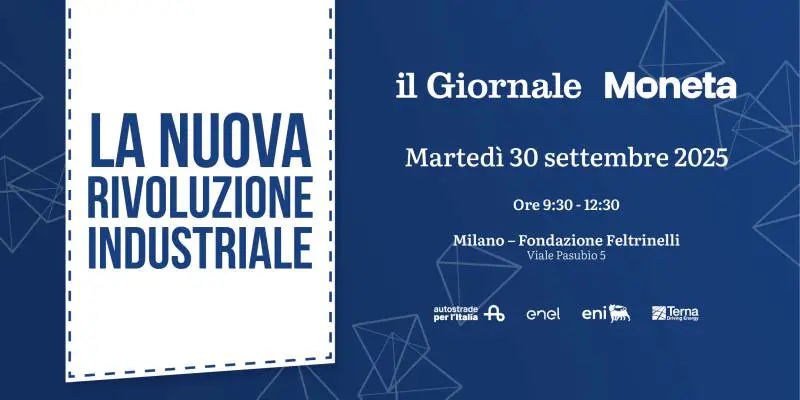
L'ingresso è gratuito previa registrazione qui: https://shorturl.at/2iDM8
Inutilità. E se fosse questo il destino dell’umano? No, non come genere, ma come coscienza profonda di ogni individuo, incredulo, tormentato e condannato a cercare il senso della sua vita secondo per secondo. È qualcosa che va oltre il senso di vuoto metafisico che pesa dopo la morte di Dio, certificata dalla ragione e rinnegata dal sentimento. È sentirsi inutile perché in effetti non sai cosa fare. Non servi più. Ci puoi essere o non essere ma le tue cose, le cose umane, vanno avanti lo stesso. È un peccato di arroganza. L’umano sradica Dio, fino a condividerne l’irrilevanza, come se l’uno senza l’altro fossero nulla. L’intelligenza, quello che tutto muove, finisce altrove, non nello spirito, non nella carne, ma nelle macchine, ovvero calcolo, algoritmi, apprendimento, virtualità e perfino un pizzico di fantasia. La grande paura, da sindrome millenaria, è di solito l’apocalisse: la madreterra che si ribella, il sole che si spegne, un virus silenzioso, la guerra esponenziale e nucleare che il giorno dopo lascia solo un deserto. Non si può escludere. Tutto questo fa parte delle tragiche possibilità. Ci si interroga da sempre sulla fine dei tempi. Ci sarà da qualche parte un punto di non ritorno, l’estinzione, per colpa o per destino inevitabile. Solo che prima di tutto questo c’è da fare i conti con la metamorfosi dell’umano. Cosa diventa? La teoria dell’irrilevanza, che in fondo è solo una presa di coscienza, è più sottile. Non mette in gioco l’apocalisse, ma è una mutazione che si insinua giorno per giorno, nella quotidianità, senza strappi, adattandosi alla realtà che cambia e senza discese all’inferno, con la possibilità che non sia tutto nero, ma che a ogni passo si possa virare verso scenari positivi o negativi e tutto dipende da noi. Quella che si mette in gioco è la responsabilità. Qui non si parla di una sostituzione, perché la macchina non può prendere il posto dell’uomo. Non c’è uno scontro di “specie”, l’organico che cede all’inorganico. È solo una integrazione, dove c’è comunque da definire quale sarà il posto dell’uno e dell’altro, cosa diventa centrale e cosa invece periferico. È insomma il senso di una relazione e segna il futuro di quella che abbiamo battezzato Intelligenza artificiale. No, la macchina non riuscirà mai a pensare come l’umano, non allo stesso modo, non con la sconosciuta potenza del cervello. È lì infatti quello che non si può copiare, replicare, trasferire. Tutto il resto probabilmente sì. I robot, gli automi o l’intelligenza senza corpo possono parlare, muoversi, sentire, scrivere, lavorare di più e meglio, dipingere, cantare, curare, in qualche modo pensare, apprendere, riconoscersi, crescere, infuriarsi, e tante altre cose, persino fingere di innamorarsi alla maniera degli umani. L’intelligenza non è solo la capacità di risolvere 15 problemi. Le macchine non saranno come i loro presunti dèi. È quel “come se” che segna un confine. Il robot può avere la coscienza umana. Fino a che punto può avere invece la sua? È l’interrogativo antico sul “chi sono”: il replicante sa di essere un replicante? Ora su questa domanda, che è il cardine dell’Intelligenza artificiale forte, si può girare in tondo all’infinito e, francamente, la risposta non può arrivare dall’umano. È quella “debole” invece che ci tocca da vicino e da tempo ci accompagna nelle nostre vite. Non il replicante ma l’aiutante, quello che calcola con una velocità che non sappiamo raggiungere, quello che prevede, suggerisce, ci affianca, con la precisione che riduce gli errori, quello che fatica al posto nostro, senza sentire la fatica. È lui, senza problemi di coscienza, che cambia profondamente la struttura della società. È lui il soggetto che ci rende ogni attimo un po’ meno utili. È lui che ci regala tempo e toglie lavoro. Non è un ragionamento da luddisti. È la realtà quotidiana. È l’operaio, il tassista, il camionista, il badante, il cameriere, l’insegnante, il muratore, il revisore dei conti, l’idraulico, l’elettricista, il bancario, il rappresentante, il postino e qualsiasi colletto bianco, il tecnico di qualsiasi cosa e sì, anche il giornalista e affini. Ci saranno altri lavori? Forse, ma non copriranno quelli persi. Anche qui non è il caso di immaginare catastrofi, ma di cambiare orizzonte. Cosa accade se nella equazione del capitalismo si defila il salario? Se a lavorare saranno soprattutto le macchine, la forza e l’Intelligenza artificiale, l’impatto sarà rivoluzionario. C’è già un nome: capitalismo quattro punto zero. I nomi non dicono però tutto. Come si sa il salario diventa consumo. Guadagno e spendo. Alimento il mercato. La spesa spinge la produzione. La produzione crea lavoro. È la logica dell’economia di mercato. Se togli un pezzo però qualcosa non torna. C’è bisogno del consumatore e per averlo serve il salario. La soluzione sembra essere già qui. È il reddito universale di cittadinanza. La macchina lavora, il salario ti arriva dallo Stato, il consumo in qualche modo è assicurato, il profitto è salvo. È un racconto chiaramente schematico. L’aspetto interessante è il costo “rivoluzionario” del reddito universale di cittadinanza. Lo Stato ha in mano la tua sopravvivenza. La tua vita dipende totalmente da lui, da loro, da chi ha il potere. Ti diranno che ci sono criteri oggettivi per ottenere il “salario pubblico”, ti rassicureranno con la frase “nessuno verrà lasciato indietro”, ti chiederanno un po’ di tempo per la comunità. Solo che poi vorranno che le tue opinioni siano opportune, in linea con il bene dello Stato, e pure i tuoi pensieri vanno tarati, smussati, adattati. Distopia? Sì, sembra in effetti il canovaccio di un romanzo anti utopico. È il sapore totalitario e disumano respirato in Mondo nuovo di Aldous Huxley o in 1984 di George Orwell. Resta però il paradosso ipotetico. La strada per salvare l’apparenza del capitalismo, non lo spirito, serva un patto sostanzialmente “sovietico”. È uno scenario diffidente, da pessimista, disegnato da chi non si fida del potere, che ha la vocazione del Leviatano e in cambio della sicurezza ti libera dal fardello della libertà. Tutto questo per dire che la metamorfosi radicale dei mezzi di produzione, con l’umano che si defila, non solo mette in discussione la logica del capitalismo, ma scarnifica i valori fondamentali della liberal-democrazia, già fragili, già spolpati, già dissacrati dai demoni del nuovo secolo. Non è chiaramente una necessità. È solo una prospettiva. Nulla ci vieta di guardare al futuro con un altro sguardo. Il robot libera l’uomo dal lavoro. Niente più affanni e tanto tempo per incarnare le proprie vocazioni. È la profezia, o il senso della storia, di Karl Marx. È lì, al di là della necessità del lavoro, il regno della libertà. È la promessa finale del comunismo. “La possibilità di fare oggi questa cosa, domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come mi vien voglia, senza diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico”. Non c’è nulla di scritto e il futuro per fortuna non insegue il destino. Non c’è né l’inferno né il paradiso. C’è solo l’umanità e la sua presa di coscienza. L’Intelligenza artificiale non ci avvicina a Dio.
Non siamo creatori. Non siamo per fortuna onnipotenti. La differenza tra l’umano e la macchina è un particolare non irrilevante: forse possiamo replicare la vita, ma non avremo mai il potere di creare la morte. I robot non muoiono.
