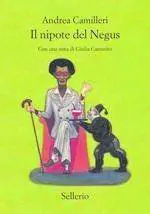
In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri torna in libreria uno dei più famosi romanzi "non montalbaniani" dello scrittore siciliano. A quindici anni dalla sua prima uscita, Sellerio ha appena ripubblicato Il nipote del Negus, un'opera carica di ironia nella quale l'autore miscela fatti storici reali (il viaggio in Sicilia del principe etiope Brhané Sillassié nel 1929) con elementi di pura fantasia, cioè la permanenza del notabile africano nelle immaginarie città di Montelusa e Vigàta, con inevitabili e equivoci ed esilaranti malintesi da parte delle autorità locali fasciste.
Il nipote del Negus non è un romanzo di ambientazione coloniale, ma così come La presa di Macallè (2003) fa riferimento al grande fenomeno di esaltazione collettiva che pervase l'Italia durante l'avventura africana che avrebbe portato, di lì a pochi anni, alla creazione dell'effimero impero mussoliniano. L'impresa coloniale in realtà era cominciata molto prima, in epoca post-unitaria, quando nel 1869 la compagnia di navigazione genovese Rubattino acquistò da un sultano locale la baia di Àssab, nel sud dell'Eritrea, e per la prima volta issò il tricolore sulla lontana terra africana. Ma non c'è dubbio che il grande impulso allo sviluppo dei possedimenti d'oltremare nel frattempo si erano aggiunti il resto dell'Eritrea, la Libia e la Somalia arrivò con il fascismo, che trasformò quel tardivo esperimento espansionistico ottocentesco in un progetto di colonizzazione senza precedenti.
Come andò a finire lo sappiamo fin troppo bene, resta il fatto che un fenomeno così complesso e profondo, che ha occupato più di un terzo della storia unitaria d'Italia, ha lasciato poche tracce nella nostra cultura. Tralasciando la memorialistica e la narrativa di propaganda promossa dal regime alla fine degli anni Venti, il romanzo coloniale è stato un genere poco frequentato dagli scrittori italiani. Con due vistose eccezioni: i primi anni del secondo Dopoguerra, con le opere fondamentali di Ennio Flaiano, Mario Tobino (Il deserto della Libia) e Giuseppe Berto (Guerra in camicia nera); e questi ultimi dieci-quindici anni, nei quali il tema coloniale è tornato con prepotenza sia come fondale di storie noir, poliziesche e ucroniche, sia come palestra per autori in cerca di facile successo con narrazioni non solo anticolonialiste, ma spesso antitaliane tout-court.
Uscito nel 1947, Tempo di uccidere è l'unico romanzo scritto da Ennio Flaiano, che fruttò allo scrittore pescarese anche la prima edizione del Premio Strega. Nata dall'esperienza personale dell'autore nella guerra d'Abissinia, l'opera è un viaggio psicologico nel delirio e nella solitudine di un ufficiale italiano che uccide involontariamente la ragazza etiope con la quale ha avuto una fugace relazione, fugge per evitare una punizione ed è attanagliato dal rimorso e dal terrore di esser stato contagiato dalla lebbra. Una vicenda che riecheggia Cuore di tenebra di Conrad e che offre l'immagine di un'Africa oscura, malata e selvaggia con cui l'uomo europeo non riesce a dialogare, sino a rischiare di perdere il senno. Il romanzo di Flaiano è lontanissimo dalla retorica fascista in auge fino a pochi anni prima, tuttavia non è un'esplicita condanna del colonialismo, come invece vorrebbe la critica letteraria contemporanea, che presenta il rapporto fra l'italiano e la donna etiope come uno stupro e quindi il simbolo stesso della sopraffazione dell'uomo bianco sulle popolazioni africane. Di recente questa rilettura dell'opera di Flaiano è stata ripresa dalla scrittrice italo-etiope Gabriella Ghermandi, che nel romanzo Regina di fiori e di perle (2007) ribalta la situazione dal punto di vista dei popoli colonizzati e fa uccidere il soldato italiano dalla ragazza abissina. Debitore delle atmosfere di Flaiano e di Conrad è anche Un mattino a Irgalem di Davide Longo, uscito nel 2001, originale mix di noir e legal thriller nel quale un improvvisato avvocato militare deve difendere un sottufficiale accusato di crimini orrendi ai danni degli indigeni nel corso della guerra d'Etiopia: un mostro alla colonnello Kurtz o un eroe caduto in disgrazia? In ogni caso un personaggio scomodo per tutti, che molti vorrebbero eliminare.
Stupri, violenze e stragi sono temi ricorrenti nella letteratura di ambientazione coloniale degli ultimi anni. Così come il famoso massacro di Debrà Libanòs del 1937, quando - dopo il sanguinoso attentato dinamitardo del movimento Giovani Etiopi contro il viceré Graziani (sette morti e cinquanta feriti) - le truppe coloniali italiane scatenarono una furiosa rappresaglia, culminata nell'assedio del monastero copto e nell'uccisione di centinaia di sacerdoti e diaconi (le fonti più recenti arrivano a stimare 1500-2000 vittime). Tutti fatti tristemente veri, anche se è opinabile ridurre un fenomeno storico durato quasi sessant'anni soltanto agli episodi sanguinari. Come se qualcuno limitasse la storia dell'impero coloniale britannico al massacro di Amritsar in India (quasi 400 morti) o allo sterminio di migliaia di boeri, tra cui donne e bambini, nei tremendi campi di concentramento in Sudafrica. Oppure, per restare al Corno d'Africa, se dell'impero del Negus Hailè Selassiè si raccontasse esclusivamente la schiavitù ancora vigente, la repressione cruenta delle minoranze etniche, l'uso in guerra delle micidiali pallottole dum-dum e le consuete evirazioni e decapitazioni dei prigionieri, sia italiani che ascari.
Eppure, a partire dagli anni Sessanta, sottotraccia i romanzi coloniali hanno un unico intento: non solo condannare il colonialismo, ma in qualche modo denigrare l'intera presenza italiana in Africa. Compresa la parentesi non coloniale dell'Afis, l'amministrazione fiduciaria della Somalia dal 1950 al 1960, che le Nazioni unite affidarono all'Italia per traghettare il Paese del Corno d'Africa verso l'indipendenza. Un'esperienza giudicata in modo positivo a livello internazionale, ma criticata invece dal giornalista e scrittore Enrico Emanuelli nel romanzo Settimana nera, uscito nel 1961 e ripubblicato da Mondadori quattro anni fa. Ambientata nella Mogadiscio degli anni Cinquanta, l'opera tende a presentare l'Afis e la presenza italiana in Somalia come una prosecuzione del peggior colonialismo, con il suo carico di sfruttamento e sopraffazione. Da ricordare en passant che Emanuelli, scomparso nel 1967, si meritò un caustico epitaffio di Indro Montanelli che ne irrideva la ritrosia, come giornalista, a criticare il regime sovietico: "Qui giace Enrico Emanuelli. Visse e non visse. Scrisse e non scrisse. Disse e non disse. Ma a nulla gli servì perché morì". Diverso l'approccio di una scrittrice post-coloniale come Erminia Dell'Oro, nata in Eritrea e poi venuta in Italia all'età di vent'anni con un bagaglio di esperienze africane che ne hanno contraddistinto l'opera. Come capita in questi casi, l'appartenenza si colloca "tra" i due luoghi, comprendendoli ed escludendoli al tempo stesso e in romanzi come Asmara addio e L'abbandono questa dualità emerge con chiarezza, così come i problemi legati alle famiglie miste italo-eritree e il tema dei figli del "madamato", il concubinaggio d'epoca coloniale. S'inseriscono sulla stessa scia i romanzi di Alessandro Spina, un altro scrittore sospeso tra i due mondi nonché uno dei pochi ad aver affrontato, dagli anni Cinquanta in poi, la storia degli italiani in Africa. Nato in Libia nel 1927 da una famiglia siriana di origine cristiano-maronita (il vero nome era Basili Khouzam), Spina è stato autore di un lungo ciclo narrativo scritto nell'arco di quasi mezzo secolo, tra il 1954 e il 1999, romanzi e antologie di racconti d'ambientazione libica che nel 2006 Morcelliana ha riunito nel volume I confini dell'ombra.
Negli ultimi anni il tema delle colonie d'Africa è stato terreno fertile per autori di noir e gialli storici. Attorno all'esecrabile massacro dei monaci copti del 1937 ruota il romanzo Debrà Libanòs di Luciano Marrocu, pubblicato nel 2002, uno dei primi interessanti esempi di utilizzo dello scenario coloniale per ambientarvi una crime-story. Infatti l'Africa coloniale compare anche nei romanzi di uno dei maestri del noir italiano, Carlo Lucarelli, autore nel 2008 de L'ottava vibrazione, un grandioso racconto corale della disfatta di Adua che tratteggia in modo impietoso il raffazzonato colonialismo italiano di fine Ottocento. Operazione poi ripetuta in altre due opere successive, Albergo Italia del 2014 e Il tempo delle iene del 2015, contraddistinte dalle indagini del capitano dei carabinieri Colaprico e dal suo collaboratore indigeno nell'Eritrea del 1899. Più o meno nello stesso periodo Daniele Cellamare ambienta il suo Delitto a Dogali, giallo storico del 2022 che ripercorre gli anni drammatici del primo colonialismo italiano partendo dal misterioso omicidio di un sacerdote, sul quale indaga un capitano del regio esercito, investigatore improvvisato.
Si ritorna agli anni Trenta con I fantasmi dell'impero di Luigi Panella, Marco Consentino e Domenico Dodaro, imponente romanzo pubblicato nel 2017 che prende le mosse da documenti d'archivio ma si incanala ben presto nell'alveo del noir e della spy-story, scandagliando il periodo controverso dell'attentato a Graziani, della repressione di Debrà Libanòs e degli intrighi tra fascisti e monarchici nell'amministrazione coloniale e nel lontano governo di Roma. Roberto Costantini, nato a Tripoli nel 1952, nei suoi romanzi affronta invece il dramma degli italiani rimasti in Libia nel Dopoguerra ed espulsi nel 1970 da Gheddafi, nell'indifferenza complice del governo italiano. Il protagonista della Trilogia del Male (Tu sei il male, Alle radici del male e Il male non dimentica) è infatti un commissario dal passato oscuro, Michele Balistreri, nato e cresciuto in Libia, e i frequenti flash-back lo riportano a una serie di avvenimenti traumatici avvenuti a Tripoli prima del 1970.
È a cavallo tra noir e ucronia il ciclo di romanzi di Luca Ongaro, che immagina un Dopoguerra in cui l'Italia non ha perso le colonie e quindi ambienta le indagini del suo commissario Campani nell'Eritrea degli anni Cinquanta e Sessanta, ancora italiana. Più o meno lo stesso scenario del fortunato L'inattesa piega degli eventi di Enrico Brizzi (2008), picaresca avventura di un giornalista sportivo mandato per punizione a seguire il campionato di calcio della Serie Africa.
Il racconto si svolge in un immaginario 1960 nel quale l'Italia non ha perso la guerra, Mussolini è ancora vivo e le colonie africane sono ancora in piedi, anche se percorse dai fremiti della decolonizzazione e animate dai primi vagiti della cultura "beat" dei favolosi Sixties.
* Giorgio Ballario è autore di una fortunata serie di gialli ambientati nelle colonie italiane. Protagonista è il maggiore Aldo Morosini. La saga è edita dalle Edizioni del Capricorno
