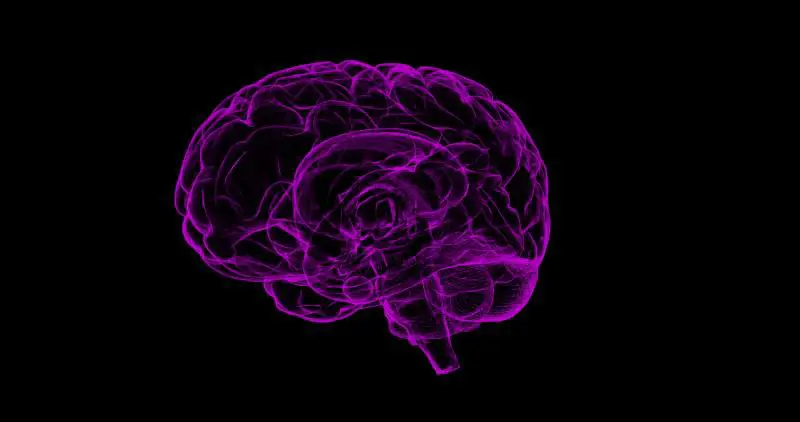
I fan di Grey's Anatomy o Dr. House sanno che il mestiere di medico, a volte, somiglia a quello di un detective. Bisogna indagare per capire di quale malattia soffra il paziente e, anche, come si possa curarlo. E questo è ancora più vero nel caso del cervello, il più affascinante, potente e misterioso dei nostri organi, così complesso da essere, in parte, ancora oscuro. Lungo le sue strade tortuose si è incamminato, molti anni fa, Fabrizio Benedetti, marchigiano, classe 1956, che da Ancona - racconta - si è trasferito a Torino nel 1971 per studiare medicina, ha preso la laurea, si è trasferito a Los Angeles per dieci anni, si è specializzato lì in neurologia e psichiatria, poi si è sposato, ha trovato «un posto a Dallas» e poi, per motivi famigliari, è tornato a Torino. Dove insegna Fisiologia umana e Neurofisiologia all'Università, oltre a dirigere il Centro ipossia di Plateau Rosà, in Svizzera.
In questi anni, Benedetti è diventato esperto di uno dei meccanismi apparentemente più incredibili del nostro cervello, il leggendario (ma reale) «effetto placebo», al quale ha dedicato Placebo Effects, una pubblicazione di rilevanza mondiale della Oxford University Press e, in forma più divulgativa, L'effetto placebo (Carocci) e La speranza è un farmaco (Mondadori). Ora questa sua attività di «investigatore del cervello» si è tradotta in un saggio/noir, Il cacciatore di ricordi (Mondadori), il cui sottotitolo è: «Quattro casi gialli per un neuroscienziato».
Professore, quindi il neuroscienziato è un detective?
«In un certo senso sì. Almeno per quello che faccio io, che è un lavoro un po' particolare, perché non studio soltanto la malattia ma anche la sua storia, quello che c'è intorno a essa e mi concentro su quanto i fattori psicologici e sociali e l'ambiente influiscano sulla malattia stessa e sul suo decorso».
Insomma indaga.
«Eh sì, indago l'ambiente intorno al paziente e, a volte, se ne scoprono delle belle... Il primo titolo che avevo pensato era L'archivio dei casi curiosi, perché ho davvero questo archivio».
Quanto è pieno?
«È pieno. Ho raccolto decine di casi. I quattro gialli sono molto particolari...»
In uno di essi, una donna sotto anestesia diventa testimone di un possibile reato. Incredibile.
«Non creda che sia così rara l'anestesia cosciente. La particolarità di questo caso è che la paziente operata sia diventata testimone a un processo, dove ha riferito qualcosa di sconcertante, a proposito di una conversazione fra chirurghi...»
Ed era attendibile?
«Il filo conduttore principale del libro sono i ricordi, ma l'altro è il dubbio: non sapremo mai, con certezza, se in sala operatoria sia andata davvero così».
Che cosa significa fare il «cacciatore di ricordi»?
«Vuol dire scavare nella memoria del paziente. C'è una frase, nel libro, che dice tutto: Io sono i miei ricordi».
È così?
«La nostra personalità, il nostro modo di agire, le percezioni, le emozioni, gli affetti: tutto è basato sulla nostra memoria; quindi, quando scavi nella mente del paziente e nell'ambiente che lo circonda, evochi dei ricordi, a volte assopiti, che possono essere tirati fuori».
Svela i misteri nascosti nella sua mente?
«Cerchiamo proprio di svelare certe memorie, non a livello cosciente, bensì attraverso una analisi profonda, condotta interagendo con la persona e anche attraverso la ricerca neurofisiologica, che indaga le risposte cerebrali e il loro legame con certi ricordi. Come nel primo caso, la maledizione di Ondina».
La sua indagine si avvale di due tipi di mezzi: gli strumenti tecnologici e la parola. Partiamo dai primi, a che cosa servono?
«Gli strumenti di indagine servono per visualizzare l'attività del cervello e, così, correlare ad essa un determinato comportamento o una certa percezione. Per esempio, le risposte elettroencefaliche a una situazione di stress, che può essere nascosta, sono l'evidenza più chiara, dal punto di vista biologico, del fatto che il corpo reagisca a uno stress interiore. Nel primo caso, l'ossessione di Sonia di aver spinto la figlia, per esempio. Poi, durante gli interventi neurochirurgici, si possono stimolare parti diverse del cervello».
E che cosa succede?
«Tutti noi, che lavoriamo come gruppo, abbiamo trovato sconcertante il caso di Genny: la stimolazione ha evocato dei ricordi nascosti che facevano riferimento a un nostro paziente precedente, Andrea».
La parola è lo strumento più importante?
«Dipende dalla situazione, ma gioca un ruolo cruciale: la storia del paziente, l'interazione con lui, quello che gli dici, come interagisci. Il mio libro La speranza è un farmaco descrive proprio la potenza della parola, la quale, dal punto di vista neurobiologico, utilizza gli stessi meccanismi dei farmaci. Anzi, dovremmo dire il contrario, visto che le parole sono nate prima dei farmaci...»
I farmaci «copiano» le parole?
«Nel nostro cervello c'è una farmacia endogena che viene attivata in certe situazioni, e che è in grado di calmare il dolore e l'ansia, farci recuperare da una depressione, farci ritrovare la speranza... I meccanismi che i farmaci e le parole utilizzano sono gli stessi, a livello cerebrale».
Per esempio?
«La morfina usa una via biochimica che silenzia il dolore; l'interazione positiva con il paziente utilizza la stessa via, cioè si attivano proprio le stesse zone, le stesse vie nervose».
È la prova che le parole possono curare, ma anche uccidere?
«Sì, c'è la prova, ed è quanto spiegano le pubblicazioni scientifiche che ho fatto, dato che ho lavorato molto sull'effetto placebo, cioè l'impatto enorme, sul benessere, dell'interazione positiva ed empatica fra medico e paziente; e, viceversa, il fatto che parole negative possano avere un effetto altrettanto negativo».
Come ha deciso di occuparsi proprio dell'effetto placebo?
«Fin da quando ero studente di Medicina ero affascinato dallo studio del cervello e delle sue patologie, perché il cervello siamo noi stessi, il nostro comportamento, le nostre emozioni e il nostro modo di percepire il mondo. Per quanto riguarda il placebo e l'interazione fra medico e paziente, tutto è cominciato durante dei trial clinici per una terapia nuova: in questi trial si fa il paragone tra il farmaco vero e il placebo, per determinare se il farmaco sia efficace».
E che cosa è emerso?
«In molti trial, soprattutto nell'ambito del dolore, del Parkinson e delle demenze mi sono accorto che chi riceveva il placebo stava meglio rispetto a chi aveva ricevuto il farmaco vero; così mi sono chiesto: perché credere di ricevere la medicina, quindi una interazione positiva, fa migliorare la condizione clinica del paziente? Che cosa succede nel suo cervello?»
E lo avete scoperto?
«Certamente sì, anche se ci sono ancora molte domande aperte. Ma il punto è che, quando ci si aspetta un beneficio terapeutico, si scatenano dei meccanismi simili a quelli dei farmaci».
Il placebo funziona anche nella psicoterapia?
«Senz'altro. Sia chiaro, le parole positive non uccidono i batteri della polmonite e non riducono la crescita di un tumore, ma sono molto efficaci in quelle patologie dove l'aspetto psicologico gioca un ruolo importante, come la depressione, l'ansia, il Parkinson o le malattie del sistema immunitario».
La storia è, essa stessa, una terapia?
«Sì, e questo significa che la storia del paziente vale quanto il dato scientifico, cioè indagare la sua mente, il suo stato psicologico e le sue interazioni sociali e ambientali fa sì che diventi un caso, tanto quanto il dato scientifico. Ed è un caso che racconta non i meccanismi della malattia quanto quelli che le stanno intorno, e che possono migliorare, o peggiorare, la condizione del paziente».
Come si svolge questa indagine?
«I protagonisti sono proprio i ricordi: scavare nella memoria del paziente ci ha permesso, in certi casi, di risolvere il problema».
Perché i ricordi hanno questo peso?
«Capire quello che è successo nel passato aiuta a elaborare una eventuale terapia: permette di capire l'origine di un disagio e, quindi, come agire di conseguenza. Anche se non sempre, purtroppo. Ma se c'è un ricordo assopito, nascosto, e viene estirpato, allora questo ci può far intuire come l'interazione con il paziente possa essere cambiata proprio sulla base di quel ricordo e arrivare all'origine del problema».
Alcuni ricordi, però, sono falsi, o alterati. Il che rende tutto ancora più un giallo...
«Certo, è il dubbio. Quello che riusciamo, o crediamo di tirar fuori, è un ricordo vero o falso? L'ossessione di Sonia è vera o falsa? Le false memorie hanno un ruolo cruciale, e gli avvocati lo sanno bene».
Perché accade?
«Perché il nostro cervello non è perfetto e, quindi, non si ricorda bene, si concentra su alcuni dettagli e non su altri. Noi riceviamo milioni di informazioni in una giornata e ne immagazziniamo all'incirca l'uno per cento; il resto scompare. Così, a volte, il cervello fa confusione».
Quanto si può scavare nella memoria?
«Non sempre è possibile andare a fondo, ahimè. I metodi sono due. Il primo è quello neuroscientifico, che dà risposte a livello cerebrale, identificando uno stress o un disagio anche se il paziente non riesce a riferire esattamente quello che vuole raccontare».
Il secondo?
«Il buonsenso. Per stabilire se un soggetto sia cosciente o no, in genere il buonsenso ci aiuta: poche domande semplici, per vedere se la persona sia in grado di descrivere il mondo intorno a sé. Sembra banale ma è vero».
La terapia/indagine vale per tutti i suoi pazienti?
«Sì, per tutti i nostri pazienti, che sono selezionati per sperimentare nuove terapie e approcci non convenzionali».
È molto lunga e approfondita, come fate?
«Abbiamo circa venti-trenta pazienti, perciò possiamo dedicarci anima e corpo a ciascuno di loro».
Perché c'è un legame così forte fra ricordi ed emozioni?
«Per prima cosa, più lo stato emotivo che proviamo è forte, per esempio una paura o una gioia enormi, più ricordiamo quel momento. E poi, più della metà dei nostri ricordi è fatta di emozioni: viviamo delle nostre emozioni, in senso positivo e negativo, e il ricordo è inscindibile dalle emozioni, si imprime nel cervello proprio con esse».
Ma esiste davvero il «pulsante della felicità», un tasto on/off nel nostro cervello?
«Guardi, facciamo spesso interventi al cervello su pazienti svegli, in anestesia locale, e non smettiamo mai di stupirci quando, stimolandolo, accadono fenomeni che fanno proprio sorgere questa domanda... Il paziente cambia improvvisamente, ha comportamenti incredibili che si attivano quando accendo l'elettrodo, e che scompaiono quando lo spengo».
E che cosa pensa quando succede?
«Ti chiedi: la felicità è dovuta all'attivazione momentanea di un centro cerebrale? E poi, quando si spegne, si passa alla tristezza?»
Secondo lei?
«La mia risposta è: sì, siamo macchine. Sì, i ricordi sono una cosa materiale. Questo è il mio punto di vista, ci sono grandi dibattiti sull'argomento, c'è chi pensa l'opposto... Io vedo la parte psicologica e quella biochimica, e considero la parte psicologica come qualcosa di biochimico, molto più complesso».
Ma è possibile indagare davvero la mente degli altri?
«Eh, le rispondo: nì. Fino a un certo punto; poi, oltre un certo limite, iniziano a sorgere i dubbi. Spesso è difficile distinguere una memoria vera da una falsa, oppure non si riesce ad andare più in là, credi di aver tirato fuori tutti i ricordi, ma ce ne sono ancora altri nascosti».
E quindi? Restano dei casi irrisolti?
«Mi definisco uno che non sa... A volte pensi di aver raggiunto la verità, e invece c'è ancora molto da scavare, e non si può.
Per una resistenza del paziente, o per un difetto dei nostri mezzi, non si riesce ad andare così in profondità nelle memorie assopite: e allora quelle memorie rimangono lì, addormentate, e non c'è modo di risvegliarle».