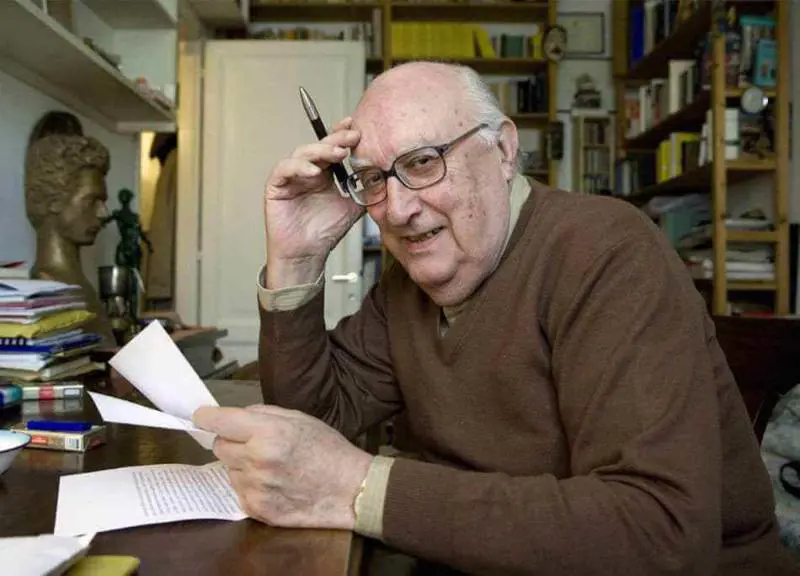
Quando si presentò per la prima volta al Noir in Festival di Courmayeur e davanti ad Andrea Pinketts e Carlo Lucarelli disse "Buongiorno, sono un giovane noirista italiano", Andrea Camilleri era effettivamente poco più di un esordiente: aveva scritto soltanto due romanzi di Montalbano. Ma grazie a quello che lui stesso chiamava "destino ritardato", quel "giovane" aveva girato la boa dei settant'anni. L'autoironia che gli faceva da carburante, la capacità di mettersi al centro della narrazione e poi sfilarsi come fanno solo i grandi personaggi, ma soprattutto la miriade di storie che sapeva raccontare ed essere: per cogliere l'essenza biografica di Andrea Camilleri ci voleva un altro grande narratore, un noirista come lui, che ha raccolto gli aneddoti raccontati da Camilleri su se stesso in tv, in radio, sui giornali, o in taccuini, quaderni e lettere. La divertita e appassionata vicinanza e lo sguardo verticale del ritrattista che lo scrittore Luca Crovi, storico collaboratore del Giornale, sviluppa negli anni verso Camilleri è riversata con generosità in Andrea Camilleri. Una storia (Salani, pagg. 288, euro 18, in uscita il 26 agosto, verrà presentato al Festivaletteratura di Mantova il 6 settembre). Si tratta della prima biografia ufficiale, in collaborazione con il fondo Camilleri, dello "scrittore italiano contemporaneo più letto, amato e discusso al mondo".
Introdotta da Mauro Novelli, questa biografia - o "album di ricordi" come Crovi la chiama - non racconta 94 anni della vita del papà di Montalbano - scomparso a Roma nel 2019 e di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, ma una sessantina, fermandosi - a parte i piatti preferiti, gli "ultimi scatti" e un gustosissimo inserto fotografico - più o meno all'altezza di un miracolo: nel 1986, a Porto Empedocle, si consuma la prima strage di mafia. Davanti al bar Albanese di via Roma, i killer uccisero sei persone, fra i quali un innocente, nel regolamento di conti tra i clan Grassonelli e Messina. Camilleri, già scrittore e sceneggiatore di successo, conosce poco le nuove leve della criminalità. Si trova nel bar, viene invitato al tavolo di Gigi Grassonelli e ha il tempo di dire: "Un attimo, vado a prendere il whisky che ho già ordinato e vengo a salutarvi". Arrivano due cabriolet piene di killer che iniziano a sparare: Camilleri viene sfiorato, prova a reagire, vede i killer in volto, sopravvive. Calogero è il secondo nome di Camilleri e quel giorno era il 21 settembre, san Calogero. Alla mafia Camilleri voleva dare poco spazio, ma cresce, inevitabilmente, in mezzo al suo potere sul territorio: Don Masino, che gestisce la casa della famiglia di origine, ufficialmente è pastore, ma in realtà appartiene a ben altra attività: farà ritrovare ai Camilleri un carico di patate rubate, i ladri dovranno bussare alla porta e chiedere scusa.
Uno dei primi aneddoti vede Camilleri - il piccolo Nené, come lo chiamava la madre Carmelina - aprire in mutande a dieci anni la porta di casa sua a Luigi Pirandello, barba a pizzetto, feluca in testa e spadino alla cintola, cugino di nonna Carolina: terrorizzato, sveglia i suoi dal pisolino e verrà rassicurato solo dall'abbraccio tra Luigino e la nonna. Pochi anni dopo nel 1942, è la volta di una violenta illuminazione: al raduno internazionale della gioventù nazifascista a Firenze viene esposta solo la bandiera nazista. Il giovane Camilleri si alza e protesta per chiedere la bandiera italiana. La sua richiesta viene accolta, ma al termine del suo discorso il gerarca Alessandro Pavolini, allora ministro della Cultura Popolare, scende in platea, individua Camilleri, gli fa cenno di seguirlo, inizia a rimproverarlo e appena lo ha di fronte gli sferra un violento calcio al basso ventre. Camilleri finisce in ospedale ma il giorno dopo torna ad ascoltare Von Schirach, capo della Gioventù hitleriana. Quel discorso, il pestaggio e la lettura di André Malraux gli faranno perdere la fede nel fascismo e nella Chiesa, che per lui erano al tempo una sola cosa.
Crovi snocciola aneddoti e storie che sono la vita di Camilleri, ma anche la proporzione epico-picaresca dello scrittore, teatrante, poeta, soggettista, sceneggiatore, regista, attore, delegato alla produzione (e, ai suoi inizi, "raccomandato" di Giulio Andreotti: alla Minerva Film come lettore di sceneggiature, pagato in sigarette di contrabbando, e poi per il film Processo alla città di Luigi Zampa, da cui la paga modesta lo farà fuggire dopo una sola settimana). Una proporzione minuscola come il pezzetto di carta con scritto Robert Capa, che conserva dopo l'incontro con il fotoreporter ai templi di Agrigento sotto i bombardamenti del 1943. Una proporzione che profuma di mare e di triglie, come quelle che Camilleri si carica in spalla sotto la pioggia verso il covo della banda Giuliano, dopo che due banditi hanno fermato il camion su cui viaggiava per requisire un po' di pesce.
O una proporzione gargantuesca, come i nomi della letteratura che ha incontrato sul suo cammino. C'è Elio Vittorini, cui ha spedito poesie e che incontra come giovane siciliano ospite a Milano dallo zio direttore di banca. I due se ne vanno in giro per la città e, mentre Vittorini gli fa da inedito Cicerone, lo tempesta anche di domande sulla Sicilia: Camilleri capirà più tardi di aver fatto da ignaro "consulente" per Le città del mondo. C'è Pier Paolo Pasolini, che gli viene presentato da Laura Betti: "Fu un mezzo disastro perché fin da subito, quasi a pelle, non ci trovammo reciprocamente simpatici. Io a quei tempi ero iscritto al Partito Comunista ed egli, quando mi domandò di che tendenza politica fossi, cominciò ad attaccare la politica del Partito". Finché un giorno i tre sono a casa della Betti, lei e Pasolini piazzati su un letto sul quale ad un certo punto crolla un'intera asse di libri. La Betti sanguinante inveisce contro Pasolini che non le consente di alzarsi in tempo, Pasolini scoppia a ridere, vengono alle mani e a Camilleri tocca separarli. E c'è Leonardo Sciascia, di cui non divenne mai amico "di primo grado", ma col quale ebbe una serie di confronti, tra adattamenti teatrali e regie, fino al momento in cui Sciascia divenne per lui un prezioso primo lettore. Che gli consiglia, tra l'altro, per il saggio La strage dimenticata: "Andrè, troppe parole siciliane ci sono.
Tu hai scritto 'sto bellissimo libro che è Un filo di fumo... Ma stai attento, eccedendo in dialetto ti tagli comprensione. Non lo dico dal punto di vista commerciale, lo dico dal punto di vista della trasmissione di un'idea".
