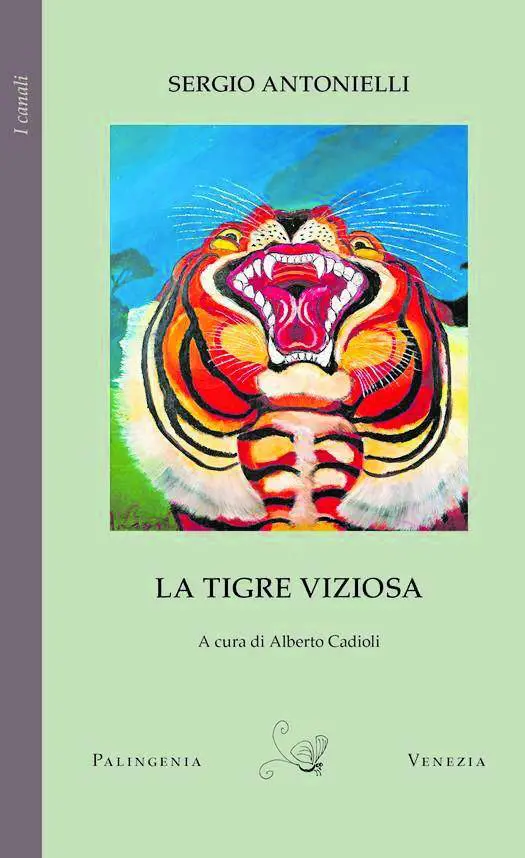
Il 24 febbraio 1954 Italo Calvino scrive a Sergio Antonielli (Roma, 1920 Milano, 1982): "La Tigre viziosa è una lieta sorpresa. L'ho letto con grande entusiasmo. È piena d'intelligenza, scritta con limpidezza, e in questa giungla ti ci muovi con perfetta disinvoltura". Un giudizio lusinghiero e autorevole, la premessa, assieme al parere di lettura di Elio Vittorini, per una rapida pubblicazione. Nel giugno del 1954 La tigre viziosa appare in libreria, pubblicato da Einaudi nella collana "I gettoni", dove apparivano i testi scelti proprio da Vittorini. Nonostante tutto questo singolare e originalissimo testo scomparirà dalla memoria, resterà dimenticato. Toccherà a Giancarlo Pontiggia di suggerire un intelligente ripescaggio, stavolta per Mondadori. La scheda di lettura è di nuovo assai positiva. Scrive Pontiggia: "La narrazione ha momenti di freschezza naturalistica alla Kipling ed è condotta con estrema coerenza realistica: il lettore, celato senza apparenti artifici nell'ottica dell'animale, ne rivive dall'interno la potenza, l'agilità, i movimenti, le reazioni: questo è reso in modo molto stimolante e spontaneo. Ma tutta la narrazione ha una suggestione intensa e una profondità insolita di significati". Al termine ne propone la ristampa. Il libro esce nuovamente nel '79 e nuovamente si smarrisce nel corso del tempo, la memoria si cancella.
Oggi è grazie a una coraggiosa e interessante iniziativa editoriale che la gemma narrativa di Sergio Antonielli torna accessibile in libreria. Dopo altri quasi 50 anni dall'edizione mondadoriana La tigre viziosa viene pubblicata per i tipi di Palingenia, ed è l'occasione per una ennesima riscoperta di questo sorprendente e misterioso racconto. Il testo è accompagnato da una interessante nota al testo del curatore Alberto Cadioli e da belle immagini che documentano l'aspetto delle precedenti edizioni del libro.
Antonielli è, soprattutto, noto come docente universitario, fu a lungo professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea alla Statale di Milano, consulente editoriale (sono note sue antologie di classici novecenteschi), ha tenuto carteggi con Montale, Sereni oltre che con Vittorini e Calvino. La sua attività di scrittore, invece, rimane assai più nell'ombra. Il motivo è, probabilmente, già nel genere di racconto. La tigre viziosa non è immediatamente catalogabile: favola allegorica, conte philosophique o romanzo psicologico?
Poi c'è la scelta del protagonista, la funzione dell'io narrante è svolta da un animale feroce, da appunto la tigre stessa evocata nel titolo enigmatico. In realtà, è questa la chiave narrativa affascinante del testo, cioè l'affido straniante della voce assoluta e dominante della storia a una bestia. Naturalmente si pensa subito, perciò all'allegoria, al repertorio d'impronta medievale, all'escamotage illuminista. Non si tratta di questo ed è spiazzante. La vita, i movimenti e perfino il linguaggio della tigre appaiono con disinvolto naturalismo, con credibile realismo, con una suggestione che riporta alla mente i racconti indiani di Kypling. La tigre è tanto reale, naturale, carnale che simbolica.
L'India descritta da Antonielli è, infatti, realistica, non è un sogno orientalista, non è immaginata grazie ai resoconti di avventurosi viaggiatori. Lo scrittore partecipò alla battaglia di El Alamein, e dopo la sconfitta cadde prigioniero. Gli inglesi lo condussero in una prigione remota. Fu costretto a vivere in cattività per tre anni a Yol, alle pendici dell'Himalaya, nell'estremo nord indiano. Ed è lì che ebbe modo di vedere i villaggi gurka che poi descrisse nei percorsi compiuti dalla tigre del racconto. Una dolorosa e radicale esperienza di esilio e segregazione, una catastrofe della storia collettiva e dell'esistenza individuale, che durò all'interno di quattro diversi campi di prigionia, dove Antonielli fu recluso insieme a diecimila altri italiani. Non ci vuole molto a capire che dietro l'enigma de La tigre viziosa c'è una tragica esperienza umana, troppo umana.
Se partiamo da questa premessa comprendiamo forse meglio il climax del libro e la sua forza simbolica perturbante. Il vizio della tigre consiste in una lenta e inesorabile corruzione della propria naturale ferocia. Il mondo primordiale si dissolve progressivamente nella misura in cui la tigre si avvicina, si mescola, desidera ibridarsi con l'elemento umano. Ciò che prima era ripugnante diventa attrattivo. Nel salto dalla natura a cultura si cela il cupio dissolvi, la pulsione di morte che attraversa il mondo. Siamo di fronte allo spettacolo destabilizzante della metamorfosi della ferocia: dai primordi bestiali alla dimensione umana. La cosa stupefacente è che l'incipit di questa prossimità all'umano matura dentro una esperienza carnivora. La tigre divora le carni dell'uomo, le assapora, ne avvisa il gusto dolciastro, e solo dopo aver sbranato comincia a desiderare un ulteriore incontro con la specie umana.
Il senso di fatalità, il puzzo, quasi avvertibile fisicamente, di morte, il destino impietoso della tigre si respirano in modo solenne e incalzante dentro le fitte pagine del libro di Antonielli. È un requiem per un mondo selvaggio, un lamento per la sua fine inesorabile. Non più intatto, non più primordiale, ma segnato dalla patologia che lo sta consumando: una pericolosa e invasiva umanizzazione. La natura, un tempo pura e inviolata, porta adesso le ferite e le cicatrici di un'esistenza che non le appartiene. È un paesaggio in lutto, dove il fragore della vita selvaggia è stato sostituito da un silenzio micidiale.
Una sostanza filosofica, metafisica, benché non astratta, è un elemento originale presente in questo libro.
Un elemento raro nella letteratura italiana novecentesca e, laddove presente, spesso poco riconosciuto e valorizzato. Si tratta di un motivo tra gli altri per leggere finalmente un bellissimo libro e augurarci che non sia daccapo dimenticato nei labirinti delle biblioteche per un altro mezzo secolo.
