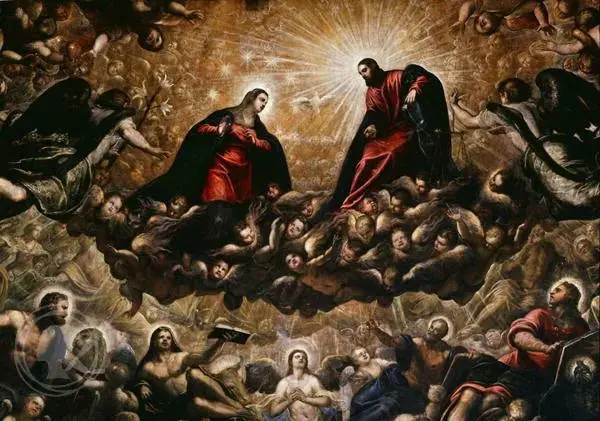
Ammiro Antonio Polito, e non da oggi. È uno dei pochissimi giornalisti italiani capaci di interrogarsi senza indulgere alla retorica e di scrivere di filosofia senza annoiare. Ora, con Qualcosa di noi resterà. Come sopravvivere alla morte (Mondadori, pagg. 168, euro 18,50), compie l'azzardo supremo: affrontare la morte, l'aldilà, la possibilità di una qualche resurrezione. Un tema che la Chiesa non predica quasi più (sbagliandosi, scrive l'autore) e i laici evitano come la peste. Lui invece ci si tuffa con il piglio dell'inviato di guerra, senza caschi teologici ma con la penna affilata da una vita di disincanto.
Polito parte da sé, come sempre. È stato comunista da giovane, lo dice con pudore ma senza scuse. Poi, quando il muro di Berlino è caduto, ha avuto il merito di capire prima di altri che non era soltanto crollato un regime, ma un'idea di salvezza terrena. Nel suo Il muro che cadde due volte aveva già confessato il lutto: il comunismo è morto, il liberalismo è malato, e neanche lui si sente tanto bene. Però non si è fermato al funerale delle ideologie: ha continuato a cercare ciò che esse, ciascuna a modo suo, promettevano senza poter mantenere la giustizia, il senso, la speranza di un destino. È l'agonia delle grandi utopie a spingerlo oggi verso l'interrogativo che le precede tutte: che cosa resta dell'uomo quando il corpo si ferma?
Il nuovo libro è una sorta di inchiesta sull'eternità. Polito lo imposta come un copione teatrale in quattro scene L'attimo, L'addio, Il dopo, La speranza con un equilibrio raro tra rigore e leggerezza. Cita filosofi, scienziati, teologi, ma soprattutto ascolta le voci di chi ha visto la soglia: medici, parenti, testimoni di esperienze di premorte. Ne esce una geografia del mistero, raccontata con l'aria di chi non crede ma non riesce più a ridere di chi crede. È la posizione più onesta del laico disincantato che ha smesso di deridere i cieli. Ha intervistato anche me. Per conflitto di interessi, evito di citarmi, spero di non avergli rovinato il libro.
Il titolo, Qualcosa di noi resterà, non è un desiderio illusorio (quello che gli inglesi chiamano wishful thinking), ma un'indagine su quella traccia che ciascuno lascia nel mondo. Per Polito la resurrezione non è un miracolo ma un lavoro: liberarsi del superfluo, accettare la finitezza, coltivare la memoria come luogo dell'immortalità. È la versione civile del "ricordati che devi morire" non per spaventare, ma per vivere meglio. La sua idea di "progetto d'immortalità" non passa per l'aldilà dei santi ma per la cura di ciò che sopravvive di noi negli altri: un gesto, una parola, un figlio che ci somiglia.
Eppure, tra le righe, si sente che la corazza dell'agnostico si è incrinata. Polito lo sa e non lo nega. La frequentazione con alcune figure cristiane da Wojtyla a Ratzinger, da Julián Carrón, il successore di don Giussani, fino ad altri biblisti e teologi gli ha lasciato addosso una fessura luminosa. Forse non crede nel Paradiso, ma riconosce la potenza di una promessa che nessuna politica sa imitare. D'altra parte, chi ha attraversato i due muri quello del comunismo e quello dell'ottimismo liberale sa che la Storia non è una marcia trionfale verso il bene. Marx e Croce, giustizieri e giustificatori, si sono sbagliati entrambi: il tempo non salva nessuno. Resta l'individuo, solo, con il suo desiderio di senso. E la domanda quella sì immortale su dove vadano a finire le anime dei giusti e degli ingiusti.
In questo Polito è più radicale di tanti credenti: non predica, non pretende. Si limita a guardare in faccia la fine e a suggerire due regole di sopravvivenza: fare ciò che si deve, come Kant; e mantenersi umili, ricordando con Amleto che "ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la tua filosofia". Non male per un ex comunista che voleva spiegare tutto con la dialettica. Ora accetta che la realtà sia più vasta dei sillogismi. È la sua resurrezione laica.
Lo stile resta il suo: asciutto, giornalistico, autoironico. Non indulge nel sentimentalismo, non recita il dolore. Parla di funerali con la stessa lucidità con cui analizza la finanziaria. Eppure commuove. Come quando confessa di aver preparato un gruppo WhatsApp con gli amici più cari, dove ogni tanto aggiorna la scaletta delle canzoni da suonare al proprio addio. "Era de maggio", scrive, "ma senza applauso finale". È un modo per esorcizzare la morte, sì, ma anche per restituirle un po' di dignità. Il che, in tempi di selfie al cimitero è già un atto rivoluzionario.
Alla fine il libro lascia addosso un sentimento raro: la gratitudine. Perché mentre la maggioranza dei suoi colleghi commenta sondaggi o scandali, Polito osa l'unico argomento che conta davvero: la fine, e ciò che forse la smentisce. È un manuale laico di sopravvivenza all'oblio, un testamento intellettuale di chi ha imparato che nessuna ideologia, nessun mercato, nessun algoritmo può sostituire la fame di eterno che ci abita. Purtroppo, temo che moriremo di fame: nessun aldilà ci accoglierà con portate succulente di amore e felicità. Ci ingoierà il nulla, questo sì eterno. (Questo lo scrivo io, non Polito, che in fondo in fondo spera: auguri sinceri).
Dopo aver rimpianto in un suo precedente volume la statura di Alcide De Gasperi e l'occasione perduta di un'Italia fondata sul premierato quella stessa riforma che oggi Giorgia Meloni tenta di realizzare Polito mostra che la vera riforma da compiere è dentro l'uomo. Non nei palazzi del potere, ma nella coscienza che sa di non essere immortale e perciò prova a meritarsi la memoria.
La politica può promettere riforme, ma solo la coscienza può tentare la resurrezione: in questa vita, perché dopo non c'è tempo.
Antonio Polito, con questo libro limpido e inquieto, ci ricorda che è ancora possibile pensarla così: laicamente, ma con tremore. Ulteriore merito: l'editorialista del Corriere della Sera ha pure il coraggio di scrivere bene. Cosa che, in Italia, è una resurrezione rara quanto una mosca bianca.
