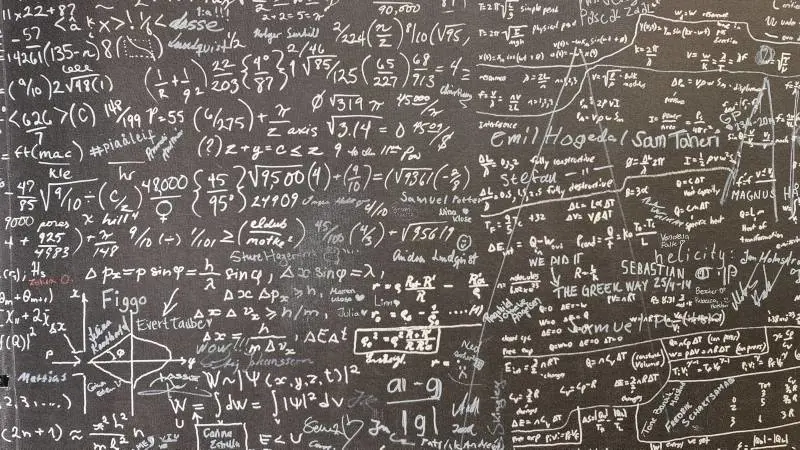
Quando il Ministro Valditara, nelle nuove indicazioni nazionali, ha avuto il coraggio di rivendicare l'importanza della cultura occidentale, si è immediatamente sollevato un coro di accuse che contestavano proprio tale importanza. Questa reazione riflette una tendenza ormai radicata: relativizzare se non sminuire il ruolo che l'Occidente ha avuto nel grande percorso culturale dell'umanità. Si proclama, spesso in maniera acritica, che tutte le culture debbano avere lo stesso peso, dimenticando che anche la nostra possiede radici profonde, antiche e inestimabili. Se siamo pronti a onorare le radici di ogni civiltà, perché mai dovremmo vergognarci o addirittura negarci il diritto di riconoscere e difendere le nostre? Tra queste radici, la matematica occupa un posto privilegiato. E sì, la matematica, come la intendiamo oggi cioè come disciplina logico-deduttiva capace di descrivere la realtà è indiscutibilmente nata in Occidente. Ovviamente esisteva una proto-matematica fin da quando l'uomo ha abbandonato la vita nomade di cacciatore-raccoglitore. La nuova società, che si andava man mano realizzando, rendeva necessario contare, misurare, stimare superfici. Gli antichi Egizi, ad esempio, dopo le alluvioni del Nilo ridisegnavano ogni anno i confini dei campi per restituire ai coltivatori la stessa estensione di terra. Il teorema di Pitagora era probabilmente noto, in forma empirica, a molte culture ben prima del filosofo di Samo. Ma perché, allora, affermiamo che la matematica l'ha inventata Pitagora? Perché Pitagora fu il primo a intuire che la matematica non fosse solo uno strumento pratico, ma il linguaggio stesso in cui è scritto il libro della Natura intuizione che Galileo, mille anni dopo, avrebbe esplicitamente proclamato. Pitagora scoprì che la musica era regolata da rapporti numerici precisi, e da lì comprese che il numero, e non solo l'osservazione, poteva descrivere l'ordine dell'universo.
Questa intuizione trovò la sua piena realizzazione con Euclide, che nei suoi Elementi costruì, partendo da soli cinque postulati, un sistema coerente di conoscenze geometriche attraverso il ragionamento deduttivo ciò che oggi chiamiamo "dimostrazione". Non è un caso che Vito Volterra, uno dei più grandi matematici italiani, abbia voluto sulla sua tomba la frase: "Muoiono gli imperi, ma i teoremi di Euclide conservano eterna giovinezza". È un monito potente: mentre le potenze politiche si estinguono, il sapere fondato sul metodo deduttivo resta intatto e sempre valido. Perfino Abraham Lincoln, ben lontano dall'essere uno scienziato, studiò gli Elementi di Euclide per affinare la propria arte oratoria, imparando la precisione logica e la struttura del ragionamento. La tecnologia moderna dalle macchine alle telecomunicazioni, dalla medicina alla conquista dello spazio si fonda proprio su quel metodo matematico che Pitagora intuì e che Euclide codificò.
E questo è pensiero occidentale. Non significa che altre civiltà non abbiano dato contributi significativi anzi, dopo la tragica fine di Ipazia e il declino della scuola di Alessandria, la fiaccola della matematica passò per secoli nelle mani di matematici indiani e arabi, che conservarono e arricchirono il patrimonio greco. Ma fino a quel momento, al di fuori dell'Occidente, la matematica non aveva superato il livello di strumento pratico per il calcolo o per la geometria elementare. Solo in Grecia essa era già diventata una scienza deduttiva universale, capace di partire da principi generali per trarre verità necessarie. Riconoscere questo primato non significa negare il valore degli altri contributi culturali. Vuol dire semplicemente essere consapevoli della nostra eredità e difenderne il posto nel mosaico della storia umana.
Se tutte le radici meritano rispetto, le nostre non possono essere tagliate in nome di un'uguaglianza che, di fatto, finirebbe per cancellare le differenze e, con esse, le ricchezze della civiltà.*Professore di Analisi Matematica
Università di Firenze
