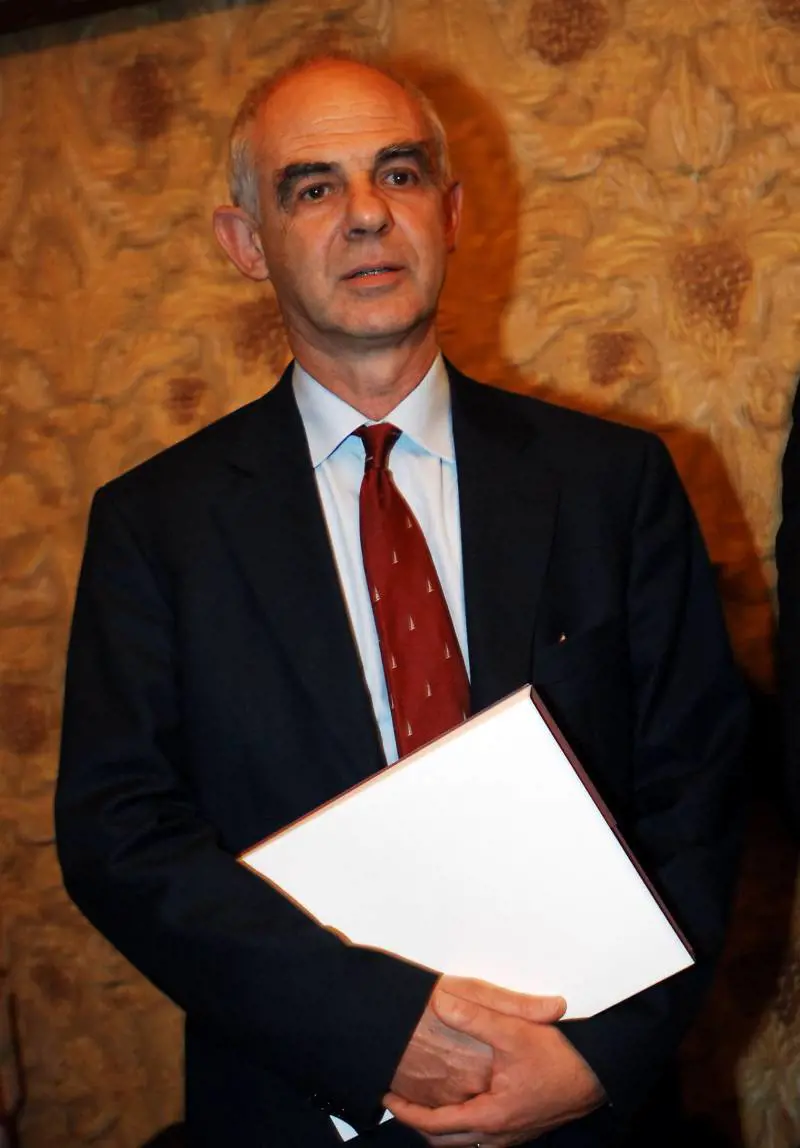
Tra gestione del Covid e la questione afghana, la Ue torna al centro dell'agenda politica. Il dibattito avviato sul Giornale da Silvio Berlusconi sul ruolo dell'Europa ha stuzzicato anche il sociologo Luca Ricolfi, docente di Analisi dei dati e intellettuale dalle intuizioni sempre sorprendenti.
Professor Ricolfi, il disimpegno Usa dall'Afghanistan ha lanciato l'urgenza di una difesa comune europea, come caldeggiato da Silvio Berlusconi sul Giornale e poi dal presidente Mattarella. È un passo necessario perché la Ue recuperi centralità?
«Sì, è tanto necessario quanto improbabile. Impieghiamo anni e anni per decidere piccole cose, abbiamo messo un anno e mezzo a far decollare il Recovery Plan, non siamo mai stati capaci di varare una politica comune di difesa dei confini. Mi sembra difficile che, su una questione delicata come la costruzione di un esercito, si riesca a trovare un accordo e a metterlo in pratica in tempi ragionevoli, cioè compatibili con la velocità con cui cambia il mondo. Ma non è solo questo, il problema. A me pare che, culturalmente, l'Europa non sia più in grado di concepire un esercito nel senso proprio del termine, ossia come macchina che può essere usata anche per operazioni belliche vere e proprie, a protezione degli interessi dei popoli europei. Se avremo un esercito sarà solo per operazioni umanitarie o di peace keeping. Lo dico brutalmente: siamo troppo civili per avere un esercito, ed è anche per questo che da tanto tempo abbiamo delegato gli Stati Uniti a proteggerci. La complicazione è che anche gli Stati Uniti stanno diventando sempre meno disponibili a intraprendere guerre non strettamente necessarie alla protezione del loro territorio».
Gli ex commissari Ue Emma Bonino e Franco Frattini denunciano l'«irrilevanza» dell'Europa. Dove invece il nostro continente rappresenta ancora una guida?
«Nella difesa dei diritti umani o, se preferiamo descrivere le cose in modo meno romantico, nel progetto di uno Stato mondiale che impone a tutti la libera circolazione dei beni, dei capitali, delle persone e delle informazioni. Un processo decollato nel 1989 ma tutt'altro che compiuto, perché richiederebbe l'esportazione della democrazia in tutto il mondo».
Lei ha studiato il fenomeno Covid. È stata efficace la regia europea nel contrastare la pandemia?
«No, è stata disastrosa, al di là dei ritardi nell'approvvigionamento dei vaccini. L'Europa è stata succube delle analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ritardato l'uso delle mascherine, il ricorso ai tamponi, il riconoscimento dell'importanza della trasmissione mediante aerosol. Ma l'errore più grande, a mio parere, è stato di non comprendere che più le frontiere vengono tenute aperte o mal sorvegliate, più diventa inevitabile il ricorso al lockdown, con tutto quel che ne segue in termini di mancata crescita. Come ha spiegato fin dall'inizio Tomas Pueyo (secondo me il più lucido analista dell'epidemia), il controllo rigoroso delle frontiere è la condizione minima per sperare di contenere o estirpare l'epidemia».
La cancelliera tedesca Angela Merkel, con l'ultimo discorso al Bundestag, esce di scena dopo 16 anni alla guida della Germania. Per l'Europa moderata si creerà un vuoto di leadership? Ripercussioni per l'Italia?
«Sì, penso che la Merkel sia difficilmente sostituibile, nessuno dei leader europei attuali (Draghi a parte) sembra avere una statura politica comparabile. Quanto all'Italia, penso due cose: primo, l'euforia pro-Draghi durerà solo a condizione che, quest'inverno, gli ospedali non tornino a riempirsi di malati Covid; secondo, la leadership di Draghi in Europa si consoliderà solo se l'Italia tornerà a crescere e si deciderà a fare le riforme che da trent'anni sappiamo di dover fare. Insomma, l'uscita di scena di Angela Merkel non consegnerà automaticamente lo scettro europeo a Mario Draghi».
Il Recovery Plan è paragonabile al Piano Marshall che ricostruì l'Europa dopo l'ultima guerra?
«Psicologicamente sì, nel senso che la politica spera (giustamente) di ricreare un clima da ricostruzione simile a quello di allora. Ma sul piano economico no: l'Italia e l'Europa del secondo dopoguerra crescevano abbastanza velocemente da ridurre il fardello del debito pubblico, noi invece stiamo cercano di crescere trascinati dal debito, con tutti i rischi che ciò comporta. Mi pare l'esatto contrario degli Anni '50».
Il mercato continentale dell'occupazione è progredito rispetto al 2004, quando Francia e Olanda bocciarono la Costituzione Ue per paura dell'«idraulico polacco» che avrebbe rubato il lavoro in tutti i Paesi?
«Sì, penso sia progredito, ma i differenziali di produttività (e quindi di salario) sono ancora troppo alti, e potrebbero allargarsi ulteriormente quando dovessero entrare paesi come Serbia, Montenegro, Albania. Per l'Italia è un grosso problema, anche oggi: se vuoi un camionista lo assumi rumeno o bulgaro, ma se vuoi uno stipendio all'altezza dei tuoi studi emigri in un paese europeo più ricco».
Lei studia da decenni la demografia e l'analisi dei flussi. Si sbilanci con una previsione: come sarà l'Unione Europea nel 2050?
«Se proprio devo azzardare una previsione vedo una frattura crescente fra i paesi in cui i tassi di istruzione sono elevati e la cultura del lavoro non è ancora morta (penso soprattutto ai paesi del Nord e dell'Est), e i paesi in cui la cultura del lavoro è in crisi, uccisa dal benessere e dall'assistenza, come accade in molti paesi mediterranei. Per questi ultimi i flussi migratori, dall'Africa e non solo, potrebbero diventare sempre più necessari per coprire posti di lavoro che le nuove generazioni non si sognano di accettare.
Questo mi sembra, in Italia, uno dei problemi centrali del programma economico-sociale della destra: se vuoi contenere i flussi migratori, non puoi permetterti il 30-35% di Neet, ossia di giovani che non studiano e non lavorano».