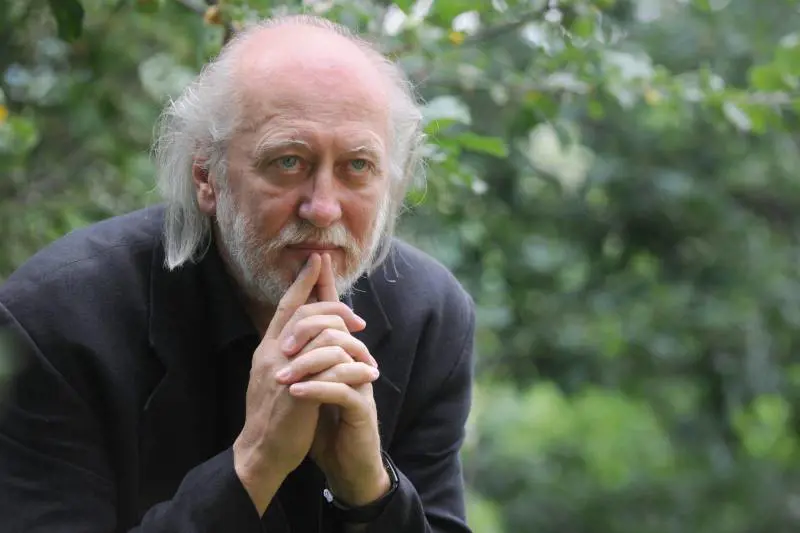
Il collega che avrebbe dovuto scrivere questo pezzo, Daniele Abbiati, quando ha saputo del Nobel a László Krasznahorkai, il "suo" ungherese, ha reagito così: "Ah, sono contento. Ma secondo me a lui non frega niente".
Non è vero, perché il diretto interessato, contattato a Francoforte, dove si trova, ha spiazzato tutti: "Sono molto contento di aver ricevuto il Premio Nobel, soprattutto perché questo premio dimostra che la letteratura esiste di per sé, al di là di tutte le aspettative non letterarie, e che viene ancora letta. E a quelli che la leggono infonde una certa speranza nel fatto che la bellezza, la nobiltà e il sublime ancora esistono in sé e per sé. Può dare speranza anche a coloro nei quali la vita è viva appena. Fiducia anche se sembra che non ve ne sia ragione".
Insomma quest'anno, finalmente, il Nobel è un riconoscimento alla Letteratura con la L maiuscola, e a uno scrittore che è uno scrittore vero. Uno di quelli che da anni si vociferava fosse papabile, come Roth, Murakami, etc etc: uno di quelli che avrebbe effettivamente meritato di vincerlo. E incredibilmente è successo. Pare uno di quei momenti di svolta dei suoi romanzi fiume, quando, senza nemmeno un punto che metta fine a una frase o a un paragrafo, nel caos degli avvenimenti che si ingarbugliano, in una atmosfera di attesa perenne, il cambiamento sembra accadere davvero, lasciando aperto lo spiraglio di una rivoluzione possibile, di una soluzione; e invece, immancabilmente, nulla cambia, se non che al vecchio declino ne segue uno nuovo, che il disastro imminente è scavalcato da un disastro procrastinato... In Melancolia della resistenza, che uscì per la prima volta in italiano per Zandonai nel 2013, prima di essere ripubblicato da Bompiani, che da quasi dieci anni è l'editore italiano di Krasznahorkai (e Dóra Várnai la sua traduttrice), e che manderà in libreria il suo nuovo romanzo, Panino non c'è più, nel 2026, leggiamo: "La gente parla di apocalisse e giudizio universale perché non sa che non ci sarà né un'apocalisse, né un giudizio universale... sarebbero completamente superflui, le cose vanno in rovina da sole, tutto si distrugge per poi ripartire di nuovo da capo, e avanti così senza sosta, evidentemente perché così deve essere". Insomma se ieri molti, riprendendo le parole di Susan Sontag e la motivazione dell'Accademia di Svezia ("per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte"), hanno acclamato Krasznahorkai come un "maestro dell'apocalisse", bisogna specificare che l'apocalisse dello scrittore ungherese ha ben poco a che fare con un senso di predestinazione, anzi, con un senso tout court, perché per lui l'esistenza, come la storia di Vasco, un senso non ce l'ha.
Sarà anche che questo susseguirsi di rivoluzioni e cambiamenti e crolli insensati Krasznahorkai li ha vissuti sulla propria pelle, essendo nato a Gyula, nell'Ungheria comunista, nel 1954 e, quindi, quando racconta di dittatori ottusi e di crisi di potere, come in Melancolia della resistenza (con cui ha vinto il Man Booker Prize nel 2015) e in Guerra e guerra, o di contadini nella povertà più disperata come in Satantango, o di gente in attesa di messia improbabili come nel Ritorno del Barone Wenckheim (con cui ha vinto il National Book Award nel 2019), scrive di quello che ha sperimentato in prima persona essere il significato della Storia. Quanto alla Budapest di oggi, preferisce Trieste, Vienna e Berlino e ieri ha detto: "Orbán e soci non finiscono di parlare della storia gloriosa ungherese, il che è oltremodo ridicolo. La storia dell'Ungheria non è altro che una serie di sconfitte". D'altra parte, in Herscht 07769 c'è un gruppo di nazisti che nella Turingia contemporanea vorrebbe tanto restaurare l'ordine grazie a un nuovo Reich. Anche in questo caso, come negli altri romanzi, c'è un eroe "buono" ma tonto, e c'è una fine del mondo incombente, pronta a spazzare via tutti, tiranni e innocenti, con la stessa violenza di un fiume in piena o, per fare un paragone fra le righe, con la stessa forza impetuosa della scrittura senza sosta di Krasznahorkai, che nasce - ha spiegato - come una melodia, come una musica di Bach; una scrittura che non solo mette in scena la guerra, la lotta, la crisi e la resistenza dell'uomo, ma è essa stessa guerra: il pólemos di Eraclito, la guerra che è padre di tutte le cose, e di tutte re, e non a caso, a metafora di questo conflitto che è il mutare incessante del tutto, per il filosofo greco c'era il fiume... E infatti, per Krasznahorkai, la realtà è inafferrabile. E, dovendo fare una sintesi "ad uso giornalistico" della sua opera, una volta ha detto di avere scritto "un unico libro" (composto dalla quadrilogia Satantango, Melancolia della resistenza, Guerra e guerra e Il ritorno del Barone Wenckheim) e che si sarebbe potuto intitolare Sconfitta; sottotitolo, Manicomio come rifugio.
Invece un po' mentiva.
Ed è bello che mentisse, anche lui, così saggio, quasi un eremita (vive in un paesino sulle colline di Szentlászló). Perché, nonostante la sconfitta e la mancanza di senso, qualcosa ci resta, ed è quel qualcosa a cui Krasznahorkai ha dedicato la sua vita: la letteratura.
