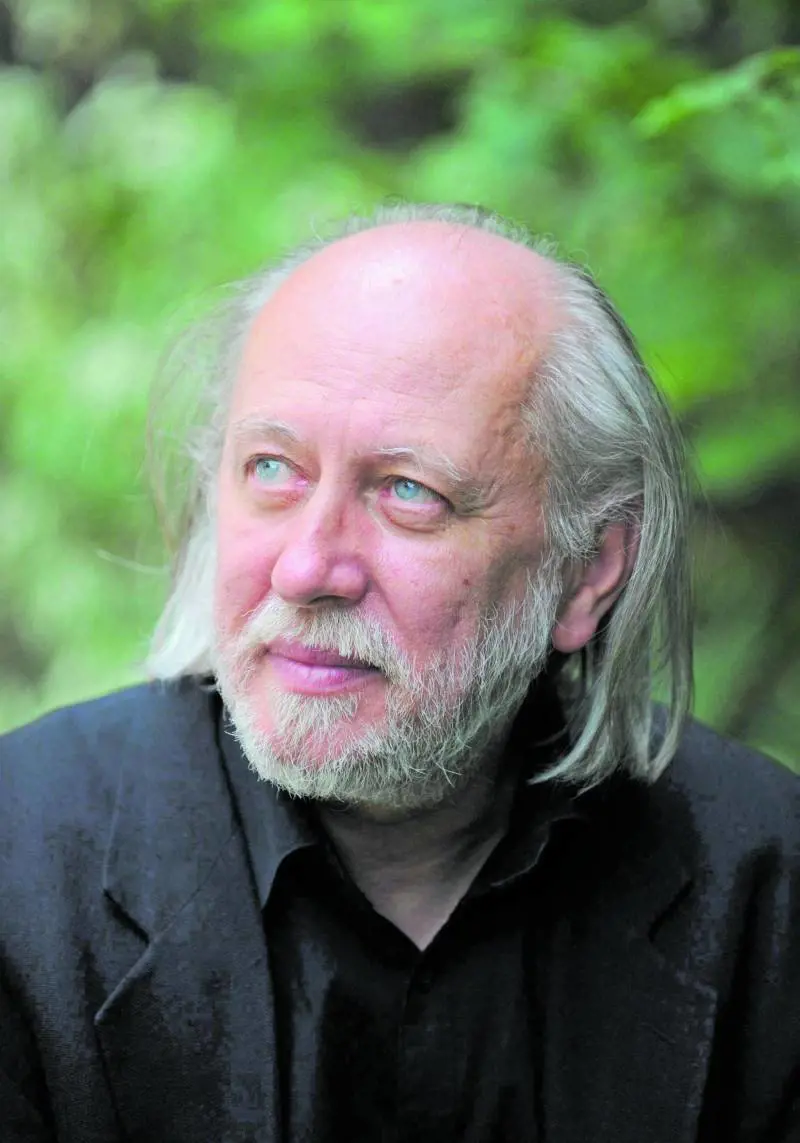
László Krasznahorkai è nato a Gyula nel 1954, nell'Ungheria comunistissima di Mátyás Rákosi. Più volte si è fatto il suo nome come possibile vincitore del Nobel per la Letteratura; lui, per ora, ha portato a casa un International Man Booker Prize (nel 2015). È celebre per i suoi romanzi fiume, come - fra quelli tradotti in italiano da Dóra Várnai e pubblicati da Bompiani - Satantango, Melancolia della resistenza, Il ritorno del Barone Wenckheim, Guerra e guerra, Herscht 07769. È appena stato a Firenze, a Testo, dove ha parlato della raccolta di racconti Avanti va il mondo (Bompiani, pagg. 352, euro 19).
László Krasznahorkai, fra i racconti ce n'è uno, La costante di Teseo, il cui protagonista è un intellettuale, tenuto prigioniero dal potere. È un personaggio autobiografico?
«Non è per niente autobiografico. Direi piuttosto che io mi affido all'immaginazione, e non alla realtà, perché la realtà è una cosa che non possiamo mai conoscere veramente. Molti sostengono di appoggiarsi a delle impressioni di realtà, ma ciò che chiamano realtà non è che una storia sulla realtà».
Invece l'immaginazione?
«La mia immaginazione è libera, e non è nemmeno collegata alla realtà. Perciò, in questo caso, potremmo dire che il nostro eroe è semplicemente arrivato dal nulla. Allo stesso tempo, però, questa immaginazione non è indipendente dalla realtà: la realtà è inconcepibilmente più ricca».
Ma questa realtà...
«Il vero problema è che la realtà non è solo molto più ricca dell'immaginazione, ma è anche inafferrabile da parte nostra. Afferrare la realtà significherebbe afferrare il presente; il presente, tuttavia, non fa che sfuggirci continuamente di mano, in due direzioni: passato e futuro. E, se ci sfugge, significa che è solo una storia semplificata sul passato o sul futuro. Nell'istante in cui potessimo afferrare il presente dell'eroe, esso scomparirebbe subito».
E quindi?
«Non ci resta altro che la nostra cosiddetta immaginazione. La quale funziona però come quando immergiamo la mano destra nel mare per afferrare l'acqua: un istante dopo non ci resta che la mano bagnata, mentre l'acqua è già sgocciolata via, in mezzo alle nostre dita. Per questo imbrogliamo, e diciamo, per esempio, che questo nostro eroe è nato a Torino, che si sente molto disilluso, e che è tenuto prigioniero da un'organizzazione segreta in un castello della Bassa Baviera; ma potremmo anche affermare qualsiasi altra cosa...».
A un certo punto, quest'uomo dice che «tutte le ribellioni riguardano il tutto». Perché?
«Ci sono tante ribellioni possibili verso vari aspetti dell'esistenza, verso singole cose; ma la ribellione di cui parla questo eroe non è nei confronti di una cosa, bensì nei confronti del tutto, di ogni cosa: nei confronti della nascita, nei confronti della morte, nei confronti della ribellione stessa...».
È anche il ruolo della letteratura?
«La letteratura non ha un ruolo».
Che cosa fa allora?
«Usa le parole per imbrogliare. Costruisce un impero immaginario e fantastico. E, a prescindere dal fatto che questo impero sia divertente o spaventoso, che ci dia speranza o che ce la tolga, che ci dica chi è l'assassino o che non ce lo sveli, una cosa comunque la fa di sicuro: ci offre un po' di consolazione, per il tempo della lettura. E noi abbiamo un grandissimo bisogno di consolazione».
I suoi romanzi, e anche i suoi racconti, sembrano avere un narratore unico. Di più: attraverso le sue frasi fiume, sembrano un'unica narrazione. È così? E perché?
«Effettivamente è così, ma non ho la più pallida idea del perché».
Ma come nascono queste sue narrazioni, diciamo così, aperte all'infinito?
«Io vivo dentro la realtà, e questa realtà all'improvviso mi colpisce in un certo punto. Immagini questo evento come se, su un dipinto immobile, tutto a un tratto apparisse un punto: è un punto che attira inesorabilmente la mia attenzione, e non posso in alcun modo resistergli, devo concentrarmi su di esso, devo immergermi in esso... e così mi ritrovo subito molto lontano. E allora devo trovare le parole adatte, devo riuscire a trovare la stessa tensione».
Quindi i suoi romanzi si formano da un'atmosfera?
«Sì, parto sempre da una atmosfera. È come un pezzo per pianoforte di Bach, o un concerto per organo, che contiene tanti elementi, narrativi e non narrativi, tanti sapori o colori, caratteristiche astratte e caratteristiche meno astratte; solo che io non uso suoni, bensì parole, per ricreare quella stessa atmosfera. E a questo punto sento già che sta succedendo qualcosa di molto importante, qualcosa di cui devo scrivere; ma non posso farlo con tante frasi brevi, ben costruite, che percepisco come artificiali, perché io ho bisogno di fare un discorso simile a quello di un pezzo musicale. Il che non significa che la mia frase non abbia una sua struttura e che scorra all'infinito senza struttura; al contrario, proprio come una struttura esiste in un pezzo di musica, esiste anche nella mia frase, che ha un suo ritmo interno, una cadenza, una melodia. Ma che non può essere fatta a pezzi in corte frasette ben levigate».
Che potere ha la lingua, in questo modo?
«Molto grande. Enorme. Incredibilmente grande».
Perché?
«Perché la lingua ci porta fino al limite. Ci porta a un confine che possiamo raggiungere solo grazie all'arte: nient'altro è in grado di farlo. E solo quando siamo fermi su questa linea di confine, solo allora possiamo percepire che, oltre al nostro mondo, ne esiste un altro».
Che cosa accade su questo confine?
«Stare su questa linea di confine è esaltante, ma allo stesso tempo ci fa anche disperare. È esaltante perché, senza, non potremmo sapere che c'è qualcosa oltre l'universo che percepiamo; ma fa anche disperare perché, anche se pensiamo di avere visto qualcosa oltre il confine, non riusciamo a definire che cosa sia quella cosa».
L'arte ci dà un assaggio del senso?
«No. Non del senso. Anzi, l'arte ci mostra proprio che l'esistenza non ha alcun senso. Il che non significa che sia insensata, ma soltanto che non è un senso quello che ha. Che cosa sia ce lo può dire solo la poesia. Come le Elegie duinesi di Rilke».
Oltre a Rilke, quali altri autori ama?
«Tantissimi. Molti italiani. Dante, ovviamente. Tomasi di Lampedusa. Cesare Pavese, per esempio, è particolarmente interessante per me perché, anche se nei suoi romanzi più famosi non è possibile dire che cosa succeda, l'atmosfera malinconica che questi romanzi trasudano è indimenticabile. Infatti restano impressi per sempre».
Lei è nato e cresciuto sotto una dittatura. La letteratura è un modo di combattere per la libertà?
«Penso che, in una dittatura, la letteratura possa essere usata proprio per questo: per sentirci liberi, anche quando non lo siamo. Sotto una dittatura, è la mancanza di libertà politica a rendere la vita brutta e disperata; in una società dove c'è la libertà politica, è la mancanza di libertà a renderci disperati e, quindi, bisognosi di ricorrere alla letteratura».
Manca comunque la libertà?
«Sì, sotto una dittatura c'è mancanza di libertà politica; in una democrazia c'è mancanza di libertà in senso assoluto. Per esempio, nei Paesi dell'Europa dell'Est, quando è venuta meno la mancanza di libertà politica, la gente si è ritrovata ad affrontare una mancanza di libertà elementare, che pervade ogni cosa».
Come condizione dell'essere umano?
«Sì, esatto. Quando una persona vive in una situazione dove manca la libertà politica, pensa che, venendo meno la dittatura, si arriverà a uno stato di vera libertà. Si illude che, da quel momento in avanti, sarà libera da tutti i punti di vista, e invece dovrà rendersi conto che non è così: non sarà libera, perché è parte della natura, e la natura non conosce la libertà».
Perciò ci serve la letteratura?
«Sì, perché quando ciò avviene l'uomo capisce con lucidità la propria situazione nell'universo».
Quindi la letteratura è consolatoria ed è legata al nostro desiderio di libertà?
«Sì, possiamo anche dire così.
È collegata alla libertà, perché fa nascere un sentimento di compassione: non dà la libertà, ma aiuta a comprendere che la mancanza di libertà è una condizione comune. Noi qui siamo, e tra di noi c'è un unico vero sentimento in comune: la compassione».
